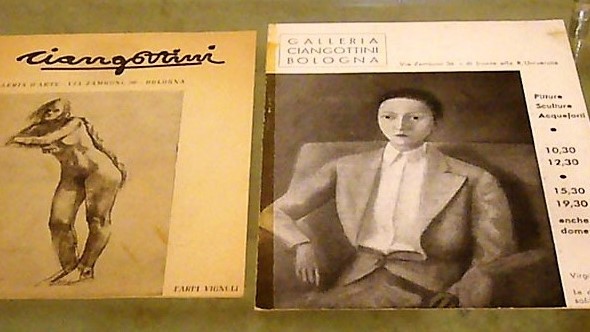Cronologia di Bologna dal 1796 a oggi
Archivio di notizie sulla storia della città e del suo territorio dal 1796 ad oggi. Con riferimenti bibliografici, link, immagini.
-
1943Dimissioni del direttore dell'Archiginnasio Albano SorbelliAlbano Sorbelli (1875-1944) lascia la direzione della biblioteca dell'Archiginnasio, tenuta dal 1904 al 1943. E' stato anche il fondatore della Biblioteca comunale popolare di Bologna nel 1909 e dal 1921 direttore della Biblioteca e Museo Carducci. Dal 1925 è docente di bibliografia e biblioteconomia alla Scuola per archivisti e bibliotecari dell'Università di Bologna. Durante la sua direzione dell'Archiginnasio la consistenza delle raccolte è aumentata prodigiosamente, soprattutto grazie alla frequenza delle donazioni di fondi e collezioni, a volte di grande pregio. Uomo di grande cultura, con notevole esperienza di studi internazionali, esperto di storia e biblioteconomia, Sorbelli ha promosso la formazione e l'aggiornamento del personale, proposto interessanti mostre bibliografiche e redatto strumenti bibliografici di livello, quali il “Bollettino dell'Archiginnasio” e il catalogo dei manoscritti della biblioteca.dettagli
-
1943La scienza del vendere di Arturo GazzoniL'imprenditore Arturo Gazzoni (1868-1951), già autore nel 1928 di un breviario sulla “scienza del vendere”, pubblica presso Zanichelli un saggio dal titolo Lezioni di pubblicità, in cui cerca di sistemare e porre su un piano scientifico le sue esperienze pionieristiche in questo campo. Gazzoni è stato tra i primi, all'inizio del secolo, ad utilizzare i migliori pittori cartellonisti e poeti come Zangarini, D'Annunzio e Trilussa, per rendere più convincente e attraente la presentazione dei propri prodotti. Si è inoltre servito di nomi illustri come testimonial. L'Antinevrotico De Giovanni ha avuto, ad esempio, i pareri positivi di tre luminari della scienza medica del tempo, come Cesare Lombroso, Guido Baccelli e Paolo Mantegazza. La Pasticca del Re Sole si è avvalsa dell'opinione entusiata di grandi attori e cantanti come Ermete Zacconi, Emma Gramatica e Beniamino Gigli. Gazzoni è consapevole della grande importanza della propaganda per l'imprenditore moderno. E' solito dire che "è inutile fabbricare dei prodotti sia pure eccellenti, se non si sanno vendere".dettagli
-
gennaio 1943Iniziative di lotta alla CalzoniNei primi mesi del 1943 alla Calzoni, antica e qualificata industria bolognese, che occupa oltre 2.000 operai, si attuano diverse iniziative di lotta sindacale e politica. Una delegazione di donne si reca in direzione e sostiene con tenacia rivendicazioni di carattere generale. Diciotto operai del forno ghisa sospendono il lavoro e vanno in direzione a protestare per le condizioni di lavoro. L'agitazione provoca l'intervento dei fiduciari di fabbrica, che attuano varie forme di intimidazione. Il tentativo di partecipare allo sciopero generale di marzo sarà contrastato dalle squadre fasciste, che arriveranno all'arresto di alcuni cittadini solidali con gli operai.dettagli
-
5 febbraio 1943Rimozione della statua del NettunoLa fontana del Nettuno è ricoperta con una struttura di protezione in legno. Sulla parete è raffigurata una mappa dei rifugi antiaerei La statua del dio del mare viene ricoverata in un deposito davanti alla lavanderia comunale di Pescarola (ora via Francesco Zanardi, 228). Tornerà in città alla fine del 1944, dopo l'istituzione della "Sperrzone", e sarà sistemata in un ricovero antiaereo nel Palazzo comunale sotto la torre dell'Orologio, a cura dell'impresa Parolini. Il Gigante sarà ricollocato al suo posto nel maggio 1946, dopo un'accurata ripulitura. Durante la guerra si spargerà questa profezia popolare: "Quando il Gigante rivedrà la luce, non ci saran più né Hitler né il Duce".dettagli
-
marzo 1943Scioperi nelle campagne e nelle fabbricheIn marzo e aprile si scatenano grandi scioperi nelle fabbriche del Nord Italia. A Bologna la lotta si sviluppa nelle campagne e in alcuni complessi industriali, come l’ACMA, il polverificio di Marano, il Pirotecnico, dove si hanno manifestazioni di protesta con temporanee sospensioni del lavoro. Nella parte orientale della città gli operai di alcune fabbriche si radunano per il loro primo sciopero politico davanti al Calzaturificio Montanari, dove è occupata soprattutto manodopera femminile. Si forma un corteo fino a porta Maggiore, dove un oratore improvvisato tiene un breve comizio. Nella Bassa entrano in agitazione le mondine di Medicina, Baricella e Bentivoglio, ma anche le operaie della ditta Comi, una fabbrica di maglie, manopole e passamontagna per l’esercito, dove è prospettata una diminuzione del cottimo. A Baricella il locale dirigente fascista è schiaffeggiato dalle operaie in sciopero. La portata delle agitazioni è ancora limitata. Le radici del movimento di protesta non sono ancora molto estese. E' appena avviata la congiunzione tra lotte per migliori condizioni di lavoro e "consapevolezza antifascista" (Preti).dettagli
-
marzo 1943Il Compianto di Niccolò dell’Arca trasferito a MinerbioCome misura di protezione da eventuali danni bellici il Compianto di Niccolò dell'Arca, capolavoro del Rinascimento, viene rimosso dalla chiesa di Santa Maria della Vita. Le preziose sculture sono imballate e trasferite nella rocca Isolani a Minerbio. Nel dopoguerra il complesso plastico sarà restaurato e a lungo esposto nella Pinacoteca Nazionale.dettagli
-
5 marzo 1943Il rifugio antiaereo della Montagnola“... Li scortò nel rifugio della Montagnola. Sotto quell’antico mucchio di rusco, gente impaurita e piena di sonno. Forse mille, forse duemila” (Liverani) Sotto la minaccia di probabili attacchi aerei sulla città è approvato dal Comune il progetto per un grande rifugio sotto la Montagnola. Come primo provvedimento viene sgomberato in fretta il magazzino comunale del Pincio, dove è depositata una grande quantità di legna e altro materiale. Si tratta dei resti di una ghiacciaia dell'antico “castello del papa”, più volte edificato, tra il XIV e il XVI secolo, nei pressi di Porta Galliera e più volte distrutto dai bolognesi. Il ricovero antibomba è appaltato alla ditta Del Fante, che innanzitutto edifica una serie di bagni, con scarico nel vicino torrente Aposa, e un rifugio antigas dotato di porte stagne, che durante la guerra sarà utilizzato come infermeria. L'allestimento del primo lotto del rifugio procederà speditamente e la consegna avverrà il 12 giugno, con un mese di anticipo rispetto al previsto. Il colosso blindato comincerà ad essere utilizzato, e spesso abitato in pianta stabile, dopo le prime incursioni aeree, in particolare dopo quella disastrosa del 24 luglio, che colpirà in più punti il centro cittadino. Il primo lotto sarà in seguito prolungato con un enorme tubo in muratura, che porterà la capienza complessiva a 2.500 persone. Nel 1944 saranno aggiunte altre gallerie, con ingressi dal giardino della Montagnola, da via Indipendenza e da via del Pallone. Intitolato, dopo la sua uccisione, all'ex segretario del PNF Ettore Muti (1902-1943), il grande rifugio della Montagnola sarà l'ultimo ad essere completamente sgomberato: ospiterà alcune famiglie sfollate fino al 1947, ben oltre il termine del conflitto.dettagli
-
18 aprile 1943Il VI Reggimento Bersaglieri in RussiaIl VI Reggimento Bersaglieri, di stanza a Bologna, è impegnato per circa un anno sul fronte jugoslavo. Dopo circa un mese dal rientro in Italia è di nuovo mobilitato e inviato in Sicilia, destinato al fronte africano. Per un contrordine improvviso il RGT è inviato sul fronte russo (CSIR), raggiunto dopo due giorni di viaggio in ferrovia, attraverso Varsavia. Partecipa fino agli ultimi combattimenti alla spedizione dell'ARMIR in Russia, inquadrato nella 3ª Divisione Celere “Principe Amedeo Duca d'Aosta”. Nell'agosto-settembre 1942, “con eroici contrattacchi e con tenacissima resistenza”, arresta gli assalti russi sul Don, “rendendo vani ripetuti sfondamenti fatti dal nemico con mezzi e forze assolutamente preponderanti” (dalla motivazione della Medaglia d'Oro alla bandiera). Nel gennaio 1943 il Reggimento deve respingere l'esercito sovietico, che minaccia lo schieramento italiano. La battaglia dura dieci giorni. Il 20 febbraio i bersaglieri capitolano: i caduti sono 1.734, circa il 70% degli effettivi. La bandiera del Reggimento (decorata il 27 aprile 1943) fa ritorno in patria scortata solo dal colonnello comandante Carloni e da due sottufficiali. I superstiti del VI lasciano le armi in un campo di disinfezione e ritornano alla spicciolata alle loro case. Della III compagnia, comandata dal Capitano Aurelio Barnabè (1909-1994 - Medaglia d'Argento al V.M.), rimangono in 20 su 300. Lo stesso Barnabè, gravemente ferito il 13 agosto 1942, potrà tornare in patria grazie al sacrificio del portaordini Quinto Ascione (Medaglia d'Oro V.M. alla memoria), che lo soccorre e lo trascina a forza di braccia fino alla salvezza. I resti di molti soldati periti durante la rovinosa ritirata saranno accolti solennemente a Bologna nel 1993. Il 30 settembre 1956, a ricordo dei bersaglieri che hanno combattuto in Russia verrà solennemente inaugurata una lapide con bassorilievo dello scultore Farpi Vignoli (1907-1997) all’ingresso della caserma Manara.dettagli
-
24 aprile 1943Don Gavinelli assegnato al confinoDon Antonio Gavinelli (1885-1968), parroco del santuario del Sacro Cuore e creatore dell'Opera salesiana, è arrestato per avere stampato e diffuso un volantino contro la guerra. Sarà assegnato per tre anni al confino, da scontarsi nel convento di San Francesco a Castelvecchio Subequo (AQ). Tempo prima è stato ammonito per aver fatto stampare, in uno dei suoi foglietti domenicali, questa frase: “Né il fascismo né il comunismo salveranno l'Italia, ma piuttosto la Fede”. Lo scritto era stato portato nella sede del gruppo rionale “Nannini”, posto proprio di fronte alla sua chiesa. Pur liberato il 30 luglio, dopo la caduta del fascismo, il sacerdote rimarrà lontano da Bologna durante i mesi dell'occupazione nazifascista, e rientrerà definitivamente nel maggio 1945. Nel dopoguerra riparerà per la seconda volta (dopo il crollo del 1929) la cupola del santuario e ricostruirà la parte dell'Istituto Salesiano danneggiata dai bombardamenti. Nel 1948 realizzerà l'orfanotrofio di Castel de' Britti e negli anni Sessanta farà erigere dall'arch. Vaccaro la chiesa di San Giovanni Bosco nella periferia orientale della città. Il 14 maggio 2017, davanti al Sacro Cuore sarà inaugurata una statua in bronzo in suo onore - il primo monumento di strada della città - opera del prof. Luigi Enzo Mattei. Il 29 maggio 1943 anche Don Giuseppe Fornasini, parroco di Marzabotto, è assegnato al confino per “disfattismo politico”.dettagli
-
23 maggio 1943Arresto di Giorgio Morandi e di alcuni intellettuali azionistiTra maggio e giugno l'OVRA arresta alcuni esponenti del Partito d'Azione clandestino. Si tratta soprattutto di giovani studiosi raccolti a Bologna attorno al critico d'arte toscano Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987), uno dei fondatori di questa formazione antifascista. Tra essi Giancarlo Cavalli, Cesare Gnudi, Francesco Arcangeli, Mario Finzi, Antonio Rinaldi. Il 23 maggio anche il pittore Giorgio Morandi, frequentatore degli arrestati, è rinchiuso nel carcere di San Giovanni in Monte (matricola 5672). La sua abitazione in via Fondazza viene accuratamente perquisita. L'artista sarà scarcerato dopo una settimana per intercessione dello storico dell’arte Roberto Longhi e del collega Mino Maccari.dettagli
-
14 giugno 1943Bombardieri solitari: la Cicogna e PippoIl 14 giugno, poco dopo le 13, un aereo da ricognizione Mosquito della Royal Air Force (R.A.F.) inglese appare per la prima volta sul cielo di Bologna. Chiamato “Cicogna” per il suo carrello dalle ruote sporgenti, vola basso e fotografa gli obiettivi strategici della città: aeroporto, stazione ferroviaria, depositi di carburante, centrali elettriche, ponti e strade. Altri aerei solitari (A-20 Havoc o Baltimore) diventeranno familiari ai bolognesi con il nomignolo di “Pippo”. Voleranno normalmente ad altissima quota sopra la contraerea e saranno utilizzati per bombardare gli incroci stradali e le vie di comunicazione, oppure per disturbare le comunicazioni radio, con il lancio di migliaia di lamine argentate. Durante la notte faranno largo uso di razzi bengala, in grado di illuminare a giorno l'obiettivo o butteranno “gli spezzoni alla cieca” sulle strade cittadine. Porteranno poche bombe, ma saranno efficacissimi soprattutto per la cosiddetta "guerra psicologica". L'11 settembre 1944 “Pippo” lancerà una bomba nei pressi di Galliera, su una casa che ospita una ventina di famiglie, alcune delle quali attivamente impegnate nella Resistenza. L'esplosione provocherà cinque morti.dettagli
-
24 giugno 1943Angelo Lodini federale di BolognaAngelo (o Angiolino) Lodini è nominato federale di Bologna. Sostituisce Piero Monzoni (1896-?), divenuto prefetto a Catanzaro. Il suo vice è Walter Boninsegni, ex campione olimpico di tiro con la pistola, forse il vero detentore del potere nel PNF locale. Nelle poche settimane che rimarrà in carica, Lodini non farà nulla per riallacciare i rapporti tra il partito e la società civile, da tempo compromessi. Farà invece forti pressioni sul prefetto Letta e sul Podestà, ing. Enzo Farnè, per l’applicazione delle norme sulla difesa civile e la militarizzazione della città (Bergonzini).dettagli
-
luglio 1943Le grotte bolognesi diventano rifugiDurante la guerra le grotte bolognesi ospitano un gran numero di persone. Dopo i primi bombardamenti, nel luglio 1943, vi si rifugiano contadini delle località vicine, sfollati, renitenti alla leva, lavoratori pendolari di San Ruffillo, Ponticella e Rastignano. A volte le grotte naturali sono il rifugio di partigiani, ma anche di soldati tedeschi o americani impegnati nella zona del fronte: ad esempio il Farneto, il Sasso della Maltesca, la Buca del Diavolo, la Risorgente Acquaferedda. Per rendere la permanenza più comoda vengono stesi pagliericci e in alcuni casi è portata, con vari accorgimenti, la luce elettrica. La grotta del Farneto sarà utilizzata dall'ottobre del ‘44 come rifugio per un centinaio di civili. Abbandonata dopo una epidemia di difterite, servirà come base di transito per i partigiani, poi come ultima difesa dei soldati tedeschi, alcuni dei quali saranno qui catturati il giorno della Liberazione. La grotta Coralupo sarà attrezzata come rifugio dall'ing. Grandi, proprietario della Buini & Grandi, con l'aiuto dell’archeologo e speleologo Luigi Fantini (1895-1978). Vi verranno portate una stufa e una cucina economica. Anche qui decine di occupanti saranno costretti alla fuga da un'epidemia di difterite. Nella Risorgente dell'Acquafredda saranno ospitati renitenti e sarà costituito un deposito di armi. Una sorte particolare toccherà al cosiddetto "Buco delle gomme", dove Luigi Fantini nasconderà, nel maggio 1944, per conto dell'ing. Grandi, una ottantina di grossi pneumatici di autocarro, che saranno così sottratti alle razzie dell'esercito tedesco.dettagli
-
16 luglio 1943Primo bombardamento sulla cittàIl primo bombardamento su Bologna avviene nelle prime ore del 16 luglio. Una formazione di quadrimotori Lancaster è decollata dalle basi del Lincolnshire in Inghilterra con il compito di bombardare infrastrutture industriali e viarie lungo la via Emilia. Il bersaglio principale per Bologna è la stazione di trasformazione e smistamento dell'energia elettrica di Santa Viola. Le bombe cadono in via Agucchi, nella zona periferica di Borgo Panigale, su alcune case di operai e birocciai, che lavorano la ghiaia e la sabbia del Reno. Si contano nove morti e una ventina di feriti. Il nuovo federale del fascio, Angelo Lodini, chiede con particolare veemenza al prefetto Guido Letta e al podestà Enzo Farnè l'applicazione delle norme per la difesa e la militarizzazione della città. I controlli per il rispetto delle regole sull’oscuramento si faranno più severi, ma la difesa contraerea non migliorerà in modo significativo.dettagli
-
24 luglio 1943Disastroso bombardamento sul centro cittadinoDue formazioni di fortezze volanti americane (51 aerei appartenenti al 97. e al 99. Bomb Group del 5. Wing), partite dalle loro basi in Algeria, scaricano 150 tonnellate di bombe sullo scalo ferroviario di Bologna, considerato “the most important railway centre in Italy”. Numerosi ordigni cadono anche sul centro della città. Si registrano 163 morti e circa 300 feriti. L’Ospedale Maggiore è sorpreso nel pieno del suo funzionamento. Viene distrutto soprattutto il corpo di fabbrica su via Riva Reno e parecchie sono le vittime, tra cui il direttore della farmacia e alcuni infermieri. È colpito anche il vicino ospedale militare dell’Abbadia. I malati gravi del Maggiore vengono trasferiti al Policlinico Sant’Orsola e in altri ospedali di emergenza. Il prefetto dei Camilliani si reca immediatamente in Maternità per aiutare a trasportare i bambini nei rifugi. La chiesa gotica di San Francesco è gravemente danneggiata nella facciata e nelle navate laterali. Rovina anche una parte della chiesa di San Salvatore e l’annessa caserma Vicini. Viene colpito in via Ugo Bassi l’hotel Brun, ex palazzo Ghisilieri, già restaurato dal Rubbiani nel 1911 (nel dopoguerra sarà parzialmente ricostruito da Giorgio Ramponi e dotato all’interno di una galleria commerciale). Il sepolcro di Rolandino dé Passeggeri in piazza San Domenico è centrato da una bomba e polverizzato (verrà ricostruito integralmente nel 1949-50). Un colpo distrugge il torrione all’angolo sud-ovest del Palazzo comunale. È danneggiato anche il vicino Palazzo Montpensier (ex Caprara), sede della Prefettura, compreso lo stesso alloggio del Prefetto, che sarà ospitato per qualche tempo dal cardinale Nasalli Rocca. Molti hanno scambiato l’incursione per l’esercitazione aerea quotidiana delle 10. Il bombardamento del 24 luglio provoca lo sfollamento di tante famiglie nelle campagne e nei paesi dell’Appennino. Le più piccole delle orfanelle di San Luca sono accolte da mons. Sermasi presso l’Abbazia di Monteveglio. Il 4 agosto Bologna è dichiarata città soggetta allo sfollamento. Nelle case e nei granai dei contadini la popolazione si moltiplica. Molti lasciano la città solo provvisoriamente, uscendo nelle ore serali per ritornare a lavorare durante il giorno. Nonostante i proclami rassicuranti delle autorità, nelle settimane seguenti, a causa delle ripetute, massicce incursioni alleate, i commercianti e la gran parte degli abitanti ancora presenti abbandoneranno il centro cittadino.dettagli
-
25 luglio 1943Si diffonde la notizia della destituzione di MussoliniNella notte tra il 24 e il 25 luglio al Gran Consiglio del Fascismo Dino Grandi (1895-1988), ambasciatore in Vaticano, presenta un ordine del giorno di sfiducia a Mussolini. La sua mozione passa con 19 voti favorevoli e 7 contrari. Il Duce viene arrestato e il Re nomina Presidente del Consiglio il generale Badoglio. La destituzione di Mussolini, annunciata dalla radio alle 22,45 del 25 luglio, è accolta a Bologna con “il più vivo entusiasmo patriottico”. Nonostante l'oscuramento, gruppi di cittadini sfilano per le strade con bandiere tricolori e ritratti del re. Anche nei comuni della provincia si tengono comizi improvvisati e festeggiamenti. Vengono distrutte statue, immagini del Duce, stemmi e simboli del fascismo, ma in generale non vi sono rappresaglie nei confronti degli esponenti del regime decaduto.dettagli
-
26 luglio 1943Manifestazioni dopo la caduta del fascismoA seguito della notizia della caduta del fascismo, il 26 luglio si svolgono manifestazioni in diversi luoghi di Bologna, convocate dal Comitato d'azione dei partiti antifascisti. In un volantino esso invita i bolognesi a radunarsi in Piazza Maggiore per reclamare “ad alta voce e potente”: “Armistizio immediato e pace con onore! Via i tedeschi dall’Italia! Scioglimento immediato della Milizia e del Partito Fascista! Punizione dei responsabili di venti anni di crimini e di ruberie e del tradimento della Nazione”. Tra gli oratori dei comizi improvvisati vi sono il commediografo Federico Zardi, il giornalista e scrittore Antonio Meluschi, la Medaglia d'Oro al V.M. Luigi Missoni e il giornalista Ezio Cesarini, il dirigente comunista Mario Peloni, il maggiore Manservisi. Gli antifascisti Filippo D'Ajutolo e Ettore Trombetti penetrano nella torre dell'Arengo ed azionano il grande battaglio del campanone, annunciando alla città la fine del regime. Un gruppo di manifestanti invade il Littoriale e abbatte in parte il monumento di Mussolini a cavallo (il bronzo rimasto servirà allo scultore Luciano Minguzzi per la fusione delle statue del Partigiano e della Partigiana di porta Lame), mentre un farsesco funerale del Duce è inscenato in piazza Umberto I (poi piazza dei Martiri). Nei quartieri sono abbattuti gli stemmi del fascio, cancellate le scritte murali e tutto ciò che ricorda la dittatura. Le autorità promettono di disperdere "col fuoco senza preavviso" qualunque assembramento. Davanti alle officine Minganti intervengono i bersaglieri. Un cittadino viene arrestato “per aver pronunciato in pubblico frasi di intonazione repubblicana”. Il prefetto Letta telegrafa al governo che il movimento popolare ha assunto "un carattere nettamente comunista". Il quotidiano cattolico L' "Avvenire d'Italia", diretto da Raimondo Manzini, esce in edizione straordinaria con il titolo: Bologna accoglie con vibrante patriottismo la suprema decisione del Sovrano e pubblica il comunicato sulle dimissioni di Mussolini, emesso alle 22,45 del 25 luglio. A Casalecchio di Reno la gente si raduna davanti alla Casa del Fascio. Una cinquantina di persone fa irruzione all'interno e butta dalle finestre documenti e ritratti del Duce. Dal portone vengono tolti i fasci d'ottone. Altri spezzano con una mazza i fasci in marmo che adornano il cavalcavia ferroviario. A San Lazzaro il ritratto del Duce vola dalle finestre del palazzo comunale. Assieme a documenti sequestrati alla Casa del Fascio e ad altri emblemi del fascismo è bruciato “tra grida che invocano la fine della guerra”. Scriverà un giorno don D. Zanini: “Cadeva il duce, e con lui il regime fascista: un'ondata di euforia percorse paesi e città, festa e baldoria ovunque. La gente s'aspettava anche la fine della guerra, ma la guerra non finì. Bastò un giorno per capire che la guerra sarebbe continuata come prima, contro ogni evidenza, contro ogni speranza”.dettagli
-
27 luglio 1943Pieni poteri all'esercito e coprifuocoUna grande folla si raduna in piazza Malpighi davanti alla sede dei sindacati fascisti, per chiedere la ricostituzione dei sindacati democratici. L'iniziativa politica è assunta dal Comitato Regionale Antifascista “Pace e Libertà”, che riunisce i partiti avversi al regime. Il Comitato spinge la popolazione a manifestare per la liberazione dei prigionieri politici, l'armistizio e la pace. La risposta delle autorità badogliane è dura. Mentre a Roma il generale Roatta ordina la cruenta repressione di ogni movimento, il generale Terzani, comandante della difesa territoriale, dichiara in un proclama alla cittadinanza che l'esercito assume pieni poteri per la tutela dell'ordine pubblico. Sono vietate tutte le manifestazioni, gli assembramenti e anche gli spettacoli cinematografici e teatrali. I militari hanno l'ordine di sparare contro chi viola il coprifuoco, in vigore dalle 21 alle 5 del mattino. In diversi punti della città gli operai subiscono le cariche dei bersaglieri e dei carabinieri con le autoblindo. Si spara davanti all'officina Minganti. Un operaio è ferito gravemente. Circa 300 manifestanti vengono arrestati.dettagli
-
30 luglio 1943Massarenti rimane in manicomioI dirigenti socialisti Fernando Baroncini e Paolo Fabbri vanno a Roma per chiedere al capo della polizia la scarcerazione di tutti i prigionieri politici detenuti a San Giovanni in Monte. Nel corso di questa missione, si recano nella casa di cura per malati mentali di S. Maria della Pietà, dove i fascisti hanno da tempo internato Giuseppe Massarenti (1867-1950). Il vecchio leader del socialismo emiliano rifiuta di uscire senza aver ottenuto una dichiarazione esplicita di sanità mentale da parte del direttore del manicomio e prolunga volontariamente la sua detenzione. Anche dopo la Liberazione continuerà a richiedere la revoca della diagnosi che giustificava l’internamento e rinvierà il ritorno a Molinella. La sua richiesta rimarrà comunque inevasa.dettagli
-
30 luglio 1943Interrompere il lavoro alle 10Un manifestino firmato dai partiti antifascisti bolognesi invita i lavoratori a interrompere ogni giorno il lavoro alle 10, manifestando il desiderio di pace e libertà immediata. Nei giorni seguenti gli operai, rientrati in fabbrica, scendono in sciopero avanzando rivendicazioni economiche e chiedono di modificare l’organizzazione interna, con il riconoscimento delle “commissioni di fabbrica”.dettagli
-
2 agosto 1943Liberazione di prigionieri politici. Il ritorno di Francesco ZanardiVengono liberati dal carcere alcuni prigionieri politici: tra essi Cesare Gnudi, Paolo Fabbri, Edoardo Volterra, Carlo Ludovico Ragghianti, Massenzio Masia, Giancarlo Cavalli, Mario Finzi. Torna libero anche il socialista Giulio Vespignani, ex garibaldino di Spagna. Consegnato dalla polizia tedesca a quella italiana, era in attesa di andare al confino. Il 20 agosto rientra dal confino di Ventotene il dirigente comunista Arturo Colombi, che sarà poco dopo nominato segretario della federazione provinciale del PCdI. Nei giorni successivi è la volta di altri attivisti comunisti: Vittorio e Celso Chini, Antonio Cicalini, Umberto Macchia, Gaetano Chiarini. Il 31 agosto, dal confino di Volta Mantovana, torna a Bologna l'ex sindaco socialista Francesco Zanardi, al quale durante la dittatura è stato impedito di risiedere in città.dettagli
-
2 agosto 1943Commissione interna alla DucatiI lavoratori della Ducati, la più grande fabbrica della provincia di Bologna con 7.000 addetti, partecipano compatti alle manifestazioni che si svolgono dal 26 al 28 luglio, dopo la caduta del Fascismo. Si astengono quindi dal lavoro fino alla fine del mese. Il 2 agosto, alla ripresa dell'attività lavorativa, proclamano due scioperi consecutivi per il riconoscimento della Commissione interna di fabbrica - la rappresentanza sindacale dei lavoratori soppressa durante il Ventennio - e per l'aumento dei salari. La lotta ottiene pieno successo.dettagli
-
4 agosto 1943Bologna dichiarata "città soggetta a sfollamento"Il 4 agosto Bologna è dichiarata “soggetta a sfollamento”. Dal 10 agosto sarà obbligatorio segnalare gli appartamenti rimasti vuoti, mentre dal 22 novembre essi saranno destinati ai sinistrati. Nel frattempo sono costruiti alloggi temporanei per i senzatetto sotto alcuni portici della periferia (San Luca, Ricovero) e in baracche di legno edificate a San Lazzaro, Castenaso, Casalecchio e Trebbo. Dopo numerosi sopralluoghi e interventi di potenziamento, il 20 ottobre sarà pubblicato un elenco di 81 ricoveri pubblici dei quali è garantita l'affidabilità in caso di bombardamento. Dal settembre del 1943, a seguito dei devastanti bombardamenti alleati e dell'occupazione dell'esercito tedesco, l'esodo dal centro cittadino sarà massiccio. Il vicino paese di San Lazzaro di Savena, per il quale è previsto un aumento del 30 percento degli abitanti, nel dicembre 1943 avrà invece 13.392 abitanti, cioè l'80 percento in più. Nel comune, risparmiato fino al giugno 1944 dai bombardamenti, traslocheranno da Bologna anche l'Ufficio Postale Ferroviario, una parte dell'Ospedale Maggiore, la Scuola magistrale, la redazione dell' "Avvenire d'Italia", la Cooperativa di consumo, la Società bolognese di elettricità, la libreria Cappelli, l'Istituto Salesiano. Un gran numero di sfollati e di attività si riverserà anche su altri centri dell'area metropolitana, quali Castel San Pietro e San Giovanni in Persiceto.dettagli
-
6 agosto 1943Verso l'unificazione dei socialistiDopo alcuni incontri preparatori, il 6 agosto si tiene nello studio dell'avv. Roberto Vighi a Palazzo Bolognini, in via Santo Stefano 18, l'assemblea generale dei socialisti delle città emiliane, alla presenza di Pietro Nenni. I partecipanti sono oltre cento. Tra essi vi sono i maggiori dirigenti bolognesi del P.S.I. e del M.U.P. Vengono approvati i tre punti principali in discussione: il rifiuto dell'attesismo e la lotta ai tedeschi occupanti, la proclamazione della repubblica, l'unificazione socialista. Gianguido Borghese, Giuseppe Bentivogli, Paolo Fabbri, Fernando Baroncini, Verenine Grazia, Alberto Trebbi, Carmine Mancinelli sono eletti delegati al Convegno nazionale di Roma, che il 25 agosto sancirà l'unificazione e la costituzione del Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP).dettagli
-
15 agosto 1943Convegno dei vertici militari italiani e tedeschi a Casalecchio di RenoGli stati maggiori di Italia e Germania si incontrano in gran segreto nella villa dell'ex ministro Federzoni alla Croce di Casalecchio, protetta da un grosso cordone di SS, per definire “un accordo sul nuovo schieramento difensivo comune”. Sono presenti i generali Rommel, Jodl e von Rintelen per la Wehrmacht e i generali Roatta, Rossi, Zanussi e Di Raimondo per lo Stato Maggiore italiano. L'incontro è burrascoso. Jodl giustifica la penetrazione tedesca in atto nella penisola come conseguenza della caduta di Mussolini. Informa inoltre della nomina di Rommel a comandante generale, suscitando le proteste del generale Roatta. Gli italiani chiedono di ritirare le loro divisioni dalla Francia e dai Balcani, incontrando la diffidenza dei tedeschi, che domandano ironicamente se vogliono impiegarle al sud contro gli americani o al Brennero contro di loro. Secondo Luciano Bergonzini l'incontro segna non solo la fine dell'alleanza militare, ma anche “l'implicita rinuncia alla sovranità nazionale” da parte dell'Italia.dettagli
-
18 agosto 1943Esce il giornale clandestino "Rinascita"Il 18 e il 28 agosto viene pubblicato il giornale clandestino “Rinascita”, organo del Comitato regionale per la Pace e la Libertà (chiamato anche “Quadripartito”). Redattore capo è Leonildo Tarozzi (1895-1980), antifascista perseguitato dal regime e condannato dal Tribunale Speciale. Il Comitato è sorto in giugno dall'intesa fra il Partito d'Azione, il Partito Socialista, il Partito Comunista e alcune personalità del mondo cattolico antifascista. In settembre si trasformerà nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN).dettagli
-
20 agosto 1943Riunione del Partito Comunista bologneseSi tiene, in un appartamento di via Fondazza, la prima riunione del Comitato federale del PCI. Partecipano alcuni dirigenti appena rientrati dal carcere e dal confino: tra essi Arturo Colombi, Gaetano Chiarini, Celso e Vittorio Ghini, Umberto Macchia, Antonio Cicalini, Nella Baroncini. La Federazione comunista bolognese conta circa 1.500 iscritti, finora costretti alla clandestinità. La struttura organizzativa di base è la cellula. Ne esiste una in tutte le fabbriche importanti della città. Viene costituito un Comitato militare del partito, con giurisdizione su Bologna, Modena e Ferrara. Ne fanno parte Vittorio Ghini (responsabile), Luigi Gaiani e Mario Pelloni. Il PCI, i cui dirigenti hanno maturato notevoli esperienze di lotta in Spagna e in Francia, diventa l'animatore principale della ricomposizione del fronte antifascista, superando vecchie chiusure settarie nei confronti degli altri partiti democratici.dettagli
-
settembre 1943Ebrei bolognesi rifugiati a CotignolaTra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945 la cittadina romagnola di Cotignola, sulle rive del Senio, diventa rifugio di sfollati, militari sbandati e perseguitati politici. Vi giungono anche decine di ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali. Tutti si salveranno grazie a una rete di protezione - pressoché unica in Italia - che coinvolge varie famiglie del luogo, i parroci, il CLN e una parte dell'amministrazione pubblica, guidata dal Commissario Prefettizio Vittorio Zanzi (1896-1985), macellaio di fede repubblicana. Le persone in cerca di protezione sono dapprima ospitate in casa di Zanzi o in quella del pittore Luigi Varoli (1889-1958), figura carismatica dell'ambiente artistico e culturale romagnolo del '900. In seguito il Commissario le fa ricoverare presso famiglie e canoniche della zona. Infine le provvede di documenti falsi, ma regolari, compilati da impiegati del comune. Tra gli ebrei che trovano soccorso a Cotignola diversi vengono da Bologna. Nel settembre 1943 vi giunge, con la moglie e la figlia, Marco Oppenheim, professore di medicina interna al Sant'Orsola, radiato nel 1938 in seguito alle leggi razziali. Fino alla Liberazione i tre rimarranno nascosti nella canonica di don Antonio Costa nella frazione di Budrio. Marco svolgerà gratuitamente una preziosa opera di assistenza per i malati e i feriti del luogo. Dalla Colunga di San Lazzaro di Savena arriva, assieme ai figli, il prof. Ubaldo Lopes Pegna, docente di filosofia e pedagogia alle Magistrali. E' stato espulso dalla scuola e la sua casa di Bologna sequestrata. Alloggiato in una stanza del centro di Cotignola, riceve aiuti e documenti falsi. Nell'inverno del 1943 la casa di Varoli accoglie il prof. Renato Pirani, noto ginecologo, assieme alla moglie e alla figlia, mentre Clara e Peppino Zuckermann sono ospitati, con le figlie, presso Michele Montanari a Barbiano. A Cotignola giunge anche la famiglia del prof. Attalo Muggia, proprietario della clinica Villa Bianca, prelevato dalle SS e scomparso nei lager. Il cognato è rifugiato presso i Medri, mentre il figlio Giorgio, nascosto con la famiglia a Massa Lombarda, viene spesso in paese con la bicicletta per curare gli ammalati di polmoni. Nel 2002 Vittorio e Serafina Zanzi, Luigi e Anna Varoli saranno insigniti della medaglia di “Giusti tra le Nazioni” dallo stato di Israele e i loro nomi accolti nel memoriale del Yad Vashem a Gerusalemme.dettagli
-
2 settembre 1943Terzo pesante bombardamento sulla cittàBologna subisce il terzo bombardamento dal cielo. Le bombe, lanciate da 74 fortezze volanti americane (del 97. e 99. Bomb Group), colpiscono in modo disastroso la stazione e le zone limitrofe e gli scali ferroviari. Via Lame, piazza VIII Agosto, via del Borgo subiscono pesanti distruzioni. Tra i monumenti colpiti le chiese dei Santi Filippo e Giacomo e di Santa Maria del Buon Pastore in via delle Lame. La Porta del Poggiale in via Nazario Sauro, uno dei superstiti torresotti della cerchia del Mille, è sbriciolata da una bomba e non sarà mai più ricostruita. Era abbellita sul lato verso il centro da un affresco di Luigi Quaini (1643-1717) - il crocifisso con ai lati la Madonna e Sa Giovanni - “ottimamente restaurato vari anni prima” (Menarini, Vianelli). Le sirene di allarme suonano dieci minuti prima dell'arrivo degli aerei. Si contano una trentina di morti e altrettanti feriti. Molte sono le bombe inesplose. Una di esse perfora diversi piani dell'edificio che ospita la ditta Atti in via Drapperie e si conficca in un mucchio di sacchi di farina riposti nel magazzino del panificio.dettagli
-
8 settembre 1943Reazioni popolari all'annuncio dell'armistizioAlle 19,42 il maresciallo Pietro Badoglio rende noto alla radio l'armistizio tra l'Italia e gli Alleati firmato a Cassibile nei giorni precedenti . Alla sera, dopo un improvvisato corteo proveniente da piazza Vittorio Emanuele II, accompagnato da canti patriottici, alcune centinaia di cittadini si radunano in via Indipendenza sotto il monumento di Garibaldi. In centro cominciano a sciamare dalle caserme gruppi di militari disarmati. Il comunista Amerigo Clocchiatti tiene comizi a più riprese in via Indipendenza, invitando i cittadini ad opporsi ai tedeschi. Alle 22 circa, compaiono tra la folla alcune camionette cariche di soldati della Wehrmacht armati. La gente li accoglie con l'invito a ritornare a casa, gridando: “La guerra è finita”. In tarda serata la notizia dell'armistizio giunge anche nelle campagne e si hanno le prime manifestazioni di giubilo, subito frenate dalla constatazione che i tedeschi stanno occupando tutte le posizioni strategiche. Nella notte dell’8 settembre, ad esempio, Bazzano è occupata con i carri armati e i militari italiani vengono subito catturati e rinchiusi in una villa fuori paese, “una specie di campo di concentramento”. Alcuni riusciranno a scappare, altri saranno deportati in Germania.dettagli
-
8 settembre 1943Riunione del Fronte Pace e Libertà, poi CLN regionaleLa sera tra l'8 e il 9 settembre, in via San Felice, si incontrano i rappresentanti di alcuni partiti antifascisti. Sono presenti Carmine Mancinelli, Fernando Baroncini, Verenin Grazia e Alberto Trebbi per il PSUP - nato in agosto dalla fusione delle formazioni socialiste PSI e MUP - Mario Jacchia per il Partito d'Azione, Leonildo Tarozzi, Mario Peloni e Verdelli per il PCI. Le prime direttive che vengono impartite dal CLN regionale ai cittadini sono: intensificare il recupero di armi; soccorrere i soldati italiani e gli ex prigionieri alleati; organizzare bande armate; impedire che il grano degli ammassi finisca ai tedeschi. I comunisti pensano di ricreare una sorta di Guardia civica, pronta a combattere gli occupanti stranieri. Dal gennaio 1944 l’avv. Mario Jacchia (nome di battaglia Rossini) ha ricevuto dal CLN di Milano il compito di Ispettore militare per l’Emilia. Da allora ha fatto spola con il capoluogo lombardo per collegare il movimento locale con quello nazionale. Il 16 settembre, in una riunione clandestina tenuta nella sartoria della moglie di Armando Quadri, in via Oberdan, il Fronte Pace e Libertà (o “Quadripartito”) diventerà la sezione regionale del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), promosso a Roma dal Comitato delle Opposizioni. L'11 settembre esso ha lanciato un appello al Paese per distruggere "il nazismo e il fascismo flagelli egualmente perniciosi alla civiltà e alla libertà del mondo".dettagli
-
9 settembre 1943Aiuto ai militari sbandatiDopo la firma dell'armistizio, l'esercito italiano, privo di ordini superiori, si sbanda. L'aiuto ai soldati italiani che, lasciate le caserme, tentano di ritornare ai paesi di residenza, è un atto di solidarietà spontanea della popolazione bolognese, ma anche il banco di prova delle prime organizzazioni resistenziali antifasciste. Si cerca di ospitare, rifocillare, dotare di abiti civili i militari in fuga, li si aiuta ad attraversare di nascosto la città, eludendo la sorveglianza dei soldati tedeschi, che subito dopo l'8 settembre hanno velocemente occupato il paese. Vengono inoltre aperti i campi di prigionia situati nei dintorni della città: soldati americani e inglesi nascosti tra le piante del vivaio Ansaloni in via Malvezza sono aiutati a fuggire. Alcuni antifascisti tentano di ottenere dai soldati armi in cambio abiti civili. Questo avviene ad esempio alla stazione di San Ruffillo, dove i ferrovieri si adoperano per bloccare i convogli di soldati diretti in Germania. Già prima del 25 luglio militanti comunisti, sotto la direzione di Mario Pelloni, hanno preso contatti con militari di varie caserme. Questi contatti servono, nei giorni dell'armistizio, “ad aiutare i soldati a sottrarsi all'arresto dei tedeschi e a venire in possesso di parecchie armi da fuoco”.dettagli
-
9 settembre 1943I soldati tedeschi occupano la cittàDalla sera dell'8 settembre un contingente tedesco acquartierato a Villa Boschi, in località Due Madonne, comincia a mettere sotto controllo le caserme, a disarmare i militari italiani e sequestrare loro le armi. Nella notte tra l'8 e il 9 “poco più di settanta soldati germanici”, al comando del tenente carrista Theo Kenda, un viennese, “fanatico mussoliniano”, che “parla speditamente l'italiano con accento veneto” (Coppola), prendono possesso della città. A mezzogiorno del 9 settembre la città è tutta nelle mani dei militari tedeschi. I reparti militari italiani, rimasti senza ordini, si arrendono senza combattere, tranne “alcuni elementi carristi”. Un breve scontro si ha nei pressi della stazione, con qualche morto. Tra la costernazione della popolazione viene sospesa la corrispondenza privata, impedito l'uso del telefono, impartite diverse “misure disciplinari”. Nei giorni successivi vengono requisiti vari edifici per i comandi e i servizi logistici. La sede di rappresentanza è fissata all'hotel Baglioni. I comandi militari della Militarkommandantur MK 1012 (con competenza per Bologna e Modena) e della Stadtkommandantur si insediano presso la Facoltà di Ingegneria in via Risorgimento. Il comandante di piazza è inizialmente il col. Helmuth Dannehl, sostituito in seguito il 1° aprile 1944 dal gen. Paul Steinbach. Il comando del cap. Saalfrank, preposto al funzionamento degli uffici civili e amministrativi, è collocato in via delle Rose 12-14. Il settore lavoro addetto alle deportazioni, guidato dal col. Friedman, si stabilisce alle Caserme rosse, una vasta area recintata a nord della Bolognina. In via S.Chiara n. 6/2, accanto ai giardini Margherita, è posta la sede delle SS (comandanti il magg. Muller e il ten. Weismann), strettamente vigilata da reparti armati. Qui, nella famigerata "stanza n. 1", si praticherà la tortura a partigiani e antifascisti. La Gestapo invece è in viale Aldini 132. La Feldgendarmerie si sistema in piazza di porta Saragozza n. 4 e le SS italiane in via Saragozza 81. La polizia di sicurezza germanica (SD) si installa in via Albergati n. 6. Altri comandi e uffici militari occupano stabili e caserme situati nella parte meridionale della città, soprattutto nella zona collinare meno esposta ai bombardamenti alleati.dettagli
-
9 settembre 1943Migliaia di militari bolognesi nei lager del ReichDei 769.000 soldati dell'esercito italiano presi prigionieri dai tedeschi dopo l'8 settembre, oltre 9.000 provengono dalla provincia di Bologna. La maggior parte dei soldati appartengono a classi comprese tra il 1920 e il 1924 e sono quindi giovani reclute poco più che ventenni. Il 70% sono soldati semplici di fanteria, dislocati soprattutto in Albania, Grecia e Dalmazia. A Bologna i comandanti militari della piazza si sono arresi agli occupanti già nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Più della metà dei soldati vengono fatti prigionieri nelle ore immediatamente successive all'armistizio. Soldati e ufficiali vengono radunati nei cortili di alcune caserme e nel piazzale della stazione, custoditi da poche decine di militari tedeschi. La quasi totalità si troveranno entro la fine del mese nelle mani del nemico. Dapprima trattenuti in campi di transito e di smistamento senza acqua e cibo, vengono poi stipati in carri bestiame e spediti in Germania e in Polonia. Alcuni riescono a fuggire durante il viaggio. A Galliera, ad esempio, poiché i treni sono costretti a rallentare nei pressi del ponte ferroviario, i prigionieri si lanciano nella scarpata e cercano rifugio in paese. Qui, come in molti altri centri, trovano aiuto nella popolazione, che li fornisce di cibo e vestiti civili e offre loro un riparo temporaneo. In alcuni casi i ferrovieri aprono i vagoni piombati pieni di soldati. I militari italiani che arrivano a destinazione - dopo un viaggio massacrante di più giorni in carri merci, senza acqua, cibo e servizi igienici - sono sottoposti fin dall'inizio a un trattamento durissimo, disumano, che contribuirà a determinare il loro rifiuto a collaborare con i nazisti e la RSI, a costo di rimanere internati. Gli IMI (Internati Militari Italiani) verranno rinchiusi in campi di prigionia (gli Oflag per gli ufficiali e gli Stalag per i sottufficiali e i soldati), posti sotto l'autorità del Comando supremo della Wehrmacht. I bolognesi saranno destinati soprattutto alle aree industriali del Reich nelle zone di Berlino e Munster. La fame, il freddo insopportabile, le violenze dei carcerieri nazisti e il lavoro durissimo saranno le costanti dei campi di prigionia. 465 internati bolognesi non faranno ritorno alle loro case, deceduti per malattia, sotto i bombardamenti, dispersi sulle navi affondate durante i trasferimenti.dettagli
-
9 settembre 1943Tentativi di resistenza nelle casermeNella serata dell'8 settembre, dopo il proclama di Badoglio, una delegazione del Comitato antifascista bolognese, formata dal socialista Carmine Mancinelli e dall'azionista Ettore Trombetti, si incontra con il comandante della difesa territoriale gen. Alberto Terziani presso il Comando del Corpo d'Armata in via del Cestello, per concordare un'azione comune tra esercito e popolazione contro i nazifascisti. Il generale oppone un netto rifiuto alla consegna di armi ai “borghesi”. La considera una proposta poco seria. Dopo avere atteso invano ordini da Roma, finirà per arrendersi al tenente Theo Kenda, comandante tedesco. Come in altre città d'Italia, alla notizia dell'armistizio, gli ufficiali superiori si mettono in borghese e fuggono, i soldati e gli ufficiali di grado inferiore rimangono consegnati nelle caserme in attesa di ordini. Un'iniziale azione di resistenza ai tedeschi si ha nella caserma di via Santa Margherita, dove la mattina del 9 settembre vengono distribuite le armi ai soldati. Dopo la dispersione della truppa, esse saranno nascoste nella vicina chiesa di San Salvatore con l'aiuto di don Guerrino Fantinato. Altri tentativi di opposizione avvengono nelle caserme del 6° Bersaglieri in via Magarotti, della cavalleria, del 3° Reggimento artiglieria e del 35° fanteria in via Urbana, oltre che in quella dei carabinieri di piazza dei Tribunali. Sfruttando l'elemento sorpresa, militanti comunisti riescono a sottrarre armi al controllo tedesco dalla polveriera posta sul colle della Guardia. A Casalecchio vengono portate via armi e munizioni dall’Albergo Reno, che ospita la Posta militare e dalla Caserma del Lido presso la chiusa del Reno. Alcuni ufficiali e soldati si danno alla macchia e andranno ad ingrossare le prime formazioni partigiane. Intanto nella stazione devastata dai bombardamenti cominciano a transitare treni carichi di soldati italiani destinati alla deportazione in Germania.dettagli
-
10 settembre 1943Morire per un po' di granoIl 10 settembre ad Anzola Emilia alcuni soldati tedeschi di presidio al locale magazzino del grano sulla via Emilia uccidono due donne, Emilia Bosi e Amelia Merighi, mentre assieme ad altre tentano di entrare nel deposito gridando “Pane, Pane!”. Nei giorni successivi all'armistizio, in molti comuni della provincia vi sono assalti - spontanei o guidati dalla Resistenza - degli ammassi granari. Il 16 settembre il prefetto Trinchero ordina la consegna immediata del grano detenuto senza giustificazione, minacciando gravi sanzioni “a norma della legge di guerra germanica”.dettagli
-
10 settembre 1943Scioperi e assalti ai magazzini alimentariAll'alba del 9 settembre, dopo l'annuncio dell'armistizio e l'inizio dell'occupazione tedesca, il direttivo del Partito Comunista decide di dichiarare lo sciopero generale nelle fabbriche e nei servizi pubblici. Dà quindi la direttiva di mobilitare la popolazione per aiutare i soldati in fuga e per impadronirsi delle armi abbandonate nelle caserme. Indica inoltre di far aprire i magazzini dell'ammasso e distribuire il grano ai cittadini, sottraendolo ai tedeschi. In città lo sciopero ha successo negli impianti ferroviari e nelle principali fabbriche, come la Ducati, la Calzoni, la Minganti, la Barbieri e dura fino al 10 settembre a Imola e a Castel Maggiore, mentre nei centri rurali si moltiplicano le astensioni dal lavoro e le manifestazioni di protesta. Numerosi sono gli assalti ai magazzini e ai silos per sottrarre grano e generi alimentari: a Bologna viene svuotato un treno fermo nello scalo del mercato ortofrutticolo. Allo scalo San Donato la folla saccheggia due vagoni d'olio d'oliva destinati alla Germania. Con pentole e tegami donne e operai raccolgono il liquido che fuoriesce dai buchi praticati nelle cisterne. Le sentinelle tedesche reagiscono sparando. Un ragazzo di vent'anni viene ucciso e altre persone risultano ferite . Alla stazione di San Ruffillo la popolazione assalta i carri merci: uomini e donne escono dai vagoni carichi di cassette, vestiti, gomme d'auto, copertoni per biciclette sottratti ai nazisti. Nei centri rurali attorno a Bologna si svolgono manifestazioni popolari, che vedono protagonisti i braccianti, impegnati in questo periodo nella gramolatura della canapa, e altri lavoratori. Il 9 a San Pietro in Casale i carabinieri intervengono a sciogliere un assembramento e vengono respinti dai manifestanti. A Ponte Ronca un colpo alla polveriera frutta una scorta di munizioni e bombe a mano. A Corticella e a Calderara i comitati popolari organizzano lo svuotamento di magazzini e mulini. Ad Anzola Emilia viene assalito un deposito di grano. Le guardie tedesche sparano e uccidono a colpi di moschetto due donne, Emilia Bosi e Amelia Merighi. In altri comuni della provincia - a Castel San Pietro, a Mordano - sono assaltati i silos del Consorzio Agrario. Il grano sottratto all'ammasso viene distribuito alla popolazione o conservato in magazzini provvisori e in parte sarà utilizzato dalle formazioni partigiane. A Rioveggio, ad esempio, su consiglio dell'arciprete don Eolo Cattani, si costituisce un comitato popolare, che distribuisce 50 kg di grano a testa a tutti gli abitanti del borgo, con il consenso dei fascisti. I Podestà, il Prefetto della Provincia e i tedeschi si affrettano, nei giorni seguenti, ad emanare bandi, che minacciano pene severe per chi non restituisce “il grano illecitamente trattenuto”.dettagli
-
10 settembre 1943La "trafila romagnola" dei generali inglesiIl 10 settembre giunge al convento di Camaldoli un gruppo di circa trenta soldati inglesi provenienti dai campi di prigionia di Arezzo e Firenze. Una decina sono generali, tra i quali l’ex governatore della Cirenaica Philip Neame e l’ex comandante della Western Desert Force Richard O’Connor. Sapendo che i tedeschi sono stati informati da un colonnello italiano della loro fuga, il priore li convince a trovare rifugio nel villaggio di Seghettina, in comune di Bagno di Romagna nei pressi dell’impervia Foresta della Lama. La notizia della presenza di alti ufficiali alleati sull'Appennino romagnolo giunge negli ambienti dell'antifascismo forlivese. Tra coloro che vanno ad incontrare gli ex prigionieri vi sono Torquato Nanni di Santa Sofia, Tonino Spazzoli, l'istruttore militare Bruno Vailati e l'ex gerarca fascista Leandro Arpinati, originario di Civitella di Romagna. Secondo lo storico don Bedeschi, quest’ultimo informa i generali sui piani tedeschi di allagamento della pianura padana e sulle “armi segrete” in mano a Hitler, confidenze ricevute da Mussolini alla Rocca delle Caminate. Per gli ufficiali più alti in grado è organizzata una fuga rocambolesca, che prevede il loro prelevamento sulla costa adriatica e l'attraversamento del fronte via mare. Il cammino è tortuoso e pieno di pericoli: inizia una vera e propria "trafila romagnola", analoga a quella che portò alla salvezza Garibaldi nel 1849. Il 19 dicembre, dopo faticosi trasferimenti tra Cesena, Forlì, Cervia, Riccione e vari tentativi di imbarco andati a vuoto, da Cattolica partirà il peschereccio della salvezza. Il giorno successivo i generali saranno salutati a Bari dai comandanti alleati Eisenhower e Alexander. Nel marzo 1944 Giorgio Bazzocchi e Arturo Spazzoli provvederanno a trasferire al sud, attraverso impervi sentieri in Toscana e nelle Marche, gli altri ex prigionieri rimasti in Appennino. Ventotto uomini su due barche giungeranno il 20 maggio sani e salvi ad Ortona, già occupata dagli inglesi. La vicenda dei generali è solo un capitolo dell’opera di solidarietà dei contadini dell’alto Appennino romagnolo - gli abitanti di Ridracoli, Strabattenza, Pietrapazza e quelli dei non lontani comuni di Santa Sofia e San Piero in Bagno - che aiuteranno tanti militari stranieri a salvarsi, mettendo a rischio la loro vita.dettagli
-
14 settembre 1943Tornano i fascistiBologna è tra le prime città in cui i fascisti ricompaiono dopo l'armistizio. Tra il 13 e il 14 settebre Enrico Cacciari e Franz Pagliani (1904-1986) riaprono la federazione. Arrestato dopo il 25 luglio per detenzione di armi e condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale Militare, Pagliani viene liberato personalmente dal carcere di San Giovanni in Monte dal tenente Kenda della Wehrmacht con il compito di “rappresentare i fascisti di Bologna” e riorganizzare il partito. Dopo l'appello di Mussolini del 15 settembre per “il ripristino di tutte le istituzioni del partito” anche la caserma della Milizia si ripopola. I posti di comando sono assegnati a militari o giovani fascisti non compromessi con la vecchia gestione del PNF. Il 18 settembre è designato come reggente del locale Partito Fascista Repubblicano (PFR) l'ufficiale di aviazione Armando Sarti. Il 15 ottobre riprendono le pubblicazioni de "L'Assalto", quindicinale della Federazione repubblicana fascista “Decima Legio”. I primi numeri sono diretti da Goffredo Coppola (1898-1945) e si caratterizzano per una ossessiva propaganda antisemita. Il capo della Provincia Montani denuncerà poco dopo, in una relazione a Mussolini, i "metodi da rivoluzione provinciale" del neofascismo bolognese, descritto come "un povero malato di epilessia". Tra le due anime del PFR locale, quella oltranzista di Pagliani e quella più moderata di Giorgio Pini (1899-1987), fondatore dell’”Assalto” e neo direttore del “Resto del Carlino”, all’inizio sarà la prima a riscuotere maggiore fiducia da parte dei tedeschi e di Mussolini.dettagli
-
16 settembre 1943Si costituisce il CLN bologneseSi costituisce la sezione bolognese del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Ne fanno parte Paolo Betti per il Partito Comunista, Francesco Colombo per i repubblicani, il socialista Verenin Grazia e Armando Quadri per il Partito d'Azione. Non partecipano ancora esponenti liberali e democristiani. La prima riunione si svolge in via Oberdan 2, nell'atelier della moglie di Quadri. In seguito la maggior parte degli incontri si terranno nella casa di Grazia in via Saragozza 158. Negli ultimi giorni di guerra la sede abituale sarà l'Istituto dei ciechi in via Castiglione, il cui direttore è il socialista Paolo Bentivoglio.dettagli
-
17 settembre 1943Nascita del PFR bolognese e ricostituzione della MiliziaIl “Resto del Carlino”, per la prima volta firmato da Giorgio Pini (1899-1987), pubblica il bando di convocazione della 67a Legione della Milizia di stanza a Bologna. Vengono formati alcuni reparti: i Volontari della morte e i Cacciatori del Reno. A comandare la Legione è chiamato Augusto Ferrazzi, poi sostituito da Gaetano Spallone. Dal gennaio ‘44 salirà al comando il ten. col. Girolamo Bacchetti. Sullo stesso numero vi è l'annuncio della nascita in città del Partito Fascista Repubblicano (PFR), costituito da Franz Pagliani (1904-1986), assieme al prof. Goffredo Coppola (1898-1945), a Walter Boninsegni (1902-1991) - campione di tiro con la pistola, più volte olimpionico - e all'oltranzista modenese Enrico Cacciari, creatura di Pagliani. Quest’ultimo sarà nominato di lì a poco direttore della “Gazzetta dell’Emilia”, quotidiano fascista repubblicano. “Fanatico, dalla penna facile” scriverà “articoli di fondo permeati di retorica e di dannunzianesimo deteriore”. (Gorrieri) Pagliani, già Vice-Federale del PNF bolognese e Direttore dell'Istituto di Patologia chirurgica dell'Università, è appena uscito dal carcere di San Giovanni in Monte, dove scontava una condanna a tre anni, grazie all'intervento del tenente Kenda della Wehrmacht. Sarà in seguito nominato da Pavolini Ispettore Regionale per l'Emilia e diventerà poi comandante della Brigata Nera Mobile "Attilio Pappalardo". Come reggente della federazione bolognese viene nominato Aristide Sarti, laureando in economia e commercio e ufficiale di aviazione, che appare come un volto nuovo, “l'immagine pulita di un giovane combattente in grado di rappresentare una discontinuità col passato” (Bergonzini). Il suo nome è emerso da una riunione di fascisti oltranzisti di vecchia data: oltre a Pagliani, Coppola, Boninsegni, Cacciari, erano presenti anche Guglielmo Montani, ex prefetto a Reggio Emilia e Piacenza, e Pietro Torri (1901-1952), già comandante delle squadre d'azione e centurione della milizia ferroviaria. Torri, Boninsegni e Cesare Simula, ex combattente e in seguito comandante dei “battaglioni della morte”, vengono scelti come vice federali di Bologna. Alla prima assemblea del PFR Sarti chiede la pena di morte per il re, per i membri del Gran Consiglio che hanno votato contro Mussolini e per i generali “complici dell'infame tradimento”. Presto però sarà in rotta con gli oltranzisti e verrà rimosso su richiesta di Pagliani per il suo atteggiamento ostile. Torri sarà a sua volta reggente e poi segretario del Fascio. Dal 10 aprile 1944 al 28 gennaio 1945 sarà commissario federale e comandante della brigata nera, quando sarà cacciato dalla città, assieme all' “anima nera” Pagliani, dal generale von Senger.dettagli
-
18 settembre 1943Costituzione del Comitato straordinario di assistenzaPochi giorni dopo la sua elezione, il Commissario prefettizio Agnoli istituisce un Comitato straordinario di assistenza, anche a seguito dei primi bombardamenti sulla città. Il Comitato è formato da rappresentanti del Genio civile, dei Vigili del fuoco, dei servizi tecnici e sanitari del Comune, delle aziende municipalizzate. Deve approntare tutte le strutture di assistenza e difesa della popolazione civile: rifugi, posti di soccorso, ospedali, centri di assistenza e ricovero per gli sfollati. Dopo il devastante bombardamento del 25 settembre, Agnoli cercherà di predisporre un piano d’emergenza di attuazione immediata con il soprintendente Alfredo Bombacci. L’insufficienza e l’inefficienza delle misure di prevenzione (centri di avvistamento, allarmi, rifugi) apparirà evidente.dettagli
-
19 settembre 1943Il Comitato di Liberazione Emilia-Romagna (CLNER) e il triumvirato insurrezionale comunistaDal Comitato “Pace e Libertà”, che riunisce forze politiche ostili al regime - PCI, PSIUP e Partito d'Azione - il 19 settembre prende vita il Comitato regionale di Liberazione Emilia-Romagna (CLNER). Presto sarà costituito anche il Comando unico militare (CUMER), diretto da Ilio Barontini (Dario, 1890-1951). Tra le componenti attive del CLNER, i comunisti sono i più contrari al cosiddetto “attendismo”, atteggiamento di rinuncia alla lotta armata teso ad evitare profondi contrasti con i tedeschi occupanti e le eventuali ritorsione sulla popolazione civile. A stimolare l'iniziativa politica e militare antifascista si adopera, nei giorni successivi all'armistizio, il responsabile della direzione del Partito comunista Arturo Colombi (1900-1983), reduce dal confino a Ventotene, al quale succede dal 19 settembre Giuseppe Alberganti (Cristallo, 1898-1980), pronto a denunciare “la mentalità attesista e opportunista”, che ha prevalso anche nel suo partito. Ex sindacalista e dirigente degli Arditi del Popolo, emigrato in Francia, commissario politico delle brigate Garibaldi nella guerra civile spagnola, confinato dal regime a Ventotene, Alberganti sarà uno dei leader più autorevoli della Resistenza in Emilia. Farà parte, assieme a Barontini e a Renato Giachetti (sostituito poi da Giuseppe Dozza), del triumvirato insurrezionale comunista, l'organo di coordinamento delle brigate Garibaldi e della 7a Gap. Composti di soli comunisti, i triumvirati insurrezionali sono presenti nelle principali città del nord. Hanno il compito di coordinare “l'azione politica e di massa del partito con l'azione militare delle formazioni partigiane” (Longo), ma soprattutto di “preparare quotidianamente l'insurrezione” e attuarla anche nel caso di non funzionamento degli organismi unitari.dettagli
-
19 settembre 1943Deportazione di soggetti “politicamente pericolosi”I primi bolognesi a raggiungere i lager nazisti sono alcuni soldati rinchiusi nel carcere militare di Peschiera, arrestati per reati commessi durante il servizio militare (diserzione, autolesionismo, ecc.). Subito dopo l’8 settembre, 19 di essi rifiutano di collaborare con l’esercito tedesco e sono inviati a Dachau, dove giungeranno il 22 settembre. Qui saranno classificati come Schutzhaftlinge (deportati per misure di sicurezza) o schiavi per il lavoro. Molti non sopravviveranno al lager. Il 19 settembre vengono arrestati a Bologna alcuni antifascisti e, per la prima volta, sono deportati nei lager tedeschi, anziché avviati al confino. Si tratta di Adelmo Capelli, Renato Gaiani, Adelmo Lolli, Celso Morini, Gaetano Trigari. Appartenenti ai partiti socialista e comunista, schedati dal Casellario centrale come “politicamente pericolosi”, hanno già scontato vari anni a Ponza e Ventotene. Le catture di oppositori politici si susseguiranno nei mesi successivi estendendosi alla provincia. Il 7 novembre, ad esempio, a Mezzolara di Budrio i fascisti locali faranno arrestare alcuni “noti sovversivi”, che finiranno nel lager di Dachau.dettagli
-
24 settembre 1943Le opere d'arte della basilica di San Domenico ritornano a BolognaIl padre provinciale Domenico Acerbi e il soprintendente ai monumenti Alfredo Barbacci organizzano il ritorno a Bologna del tesoro di San Domenico. L'operazione, rischiosa per via dei frequenti bombardamenti, è dettata dall'avvicinamento del fronte al rifugio in cui le opere d'arte erano protette dal 1943: i sotterranei della villa Aria di Marzabotto. Dopo un fortunoso trasloco a cura della ditta Gondrand, le preziose reliquie e opere d'arte sono sottratte ai militari tedeschi. Durante la notte i frati provvedono a nasconderle alla base del campanile della basilica domenicana, murando poi la porta di accesso. Alcune settimane prima la cassa con le reliquie del santo fondatore è stata messa al sicuro in una cella-rifugio ricavata a cinque metri di profondità sotto l'aula capitolare del convento, protetta da una doppia blindatura di cemento armato.dettagli
-
25 settembre 1943Un bombardamento devastanteTra le 11 e mezzogiorno la città subisce l'incursione aerea più disastrosa di tutta la guerra, soprattutto dal punto di vista delle vittime civili. 120 aerei del 97° e 99° Gruppo bomberdieri del V Stormo USAF sganciano in centro e in periferia un enorme carico di bombe: 840 ordigni da 500 libbre, per un totale di 210 tonnellate di esplosivo. Il sistema di allarme antiaereo si dimostra inefficiente: le sirene suonano quando gli aerei incursori sono già sulla città. E' sabato e molta gente affolla il tradizionale mercato della Piazzola, anch'esso colpito. Si accertano 936 morti tra i civili e più di mille feriti, ma molte altre persone, letteralmente polverizzate dalle esplosioni, risultano disperse. Un calcolo esatto dei morti di questo bombardamento non sarà mai fatto. Si parla di oltre 2.000 vittime reali. Testimoni ricorderanno di aver visto “persone che erano morte per lo spostamento dell'aria ed erano come delle statue sotto i portici, in piedi, tutte bianche, spiaccicate ferme contro i muri”. Oltre 500 edifici sono distrutti, tra i quali il teatro Verdi, l'Arena del Sole, il teatro Apollo, il cinema Italia, lo Sferisterio, il Seminario regionale, la nuova sede del "Resto del Carlino" in via Dogali, dove muoiono sette operai. Tra i monumenti colpiti ci sono le chiese del Sacro Cuore, San Martino, Santa Maria Maggiore e nuovamente San Francesco. La chiesa di San Carlo in via del Porto è gravemente danneggiata, con il crollo della volta e gravi lesioni all'interno. Un ordigno distrugge l'antica farmacia delle Lame, seppellendo il dott. Gattamorta e sua figlia. Nel locale colpito del Monte dei Pegni rimangono sepolti nove dipendenti. Centinaia di persone trovano la morte in un rifugio di fortuna ricavato in un tratto sotterraneo del canale Cavaticcio, tra le odierne vie Marconi e Leopardi, centrato in pieno da alcuni ordigni. Il bombardamento del 25 settembre provoca un grande esodo di popolazione civile da Bologna: la città appare infatti indifesa e vulnerabile. Migliaia di profughi transitano in file interminabili: a piedi, in bicicletta, i più fortunati su carri e carretti. Scappano sulle colline o in campagna, trovando provvisori rifugi presso parenti e amici. Nella valle del Samoggia sono interessati allo sfollamento soprattutto i comuni di Crespellano e Bazzano. Quest’ultimo paese sarà a sua volta colpito dal cielo il 12 ottobre. I giornali annunciano che alcune decine di sinistrati bolognesi sono ospitati nella casa del Duce a Riccione.dettagli
-
27 settembre 1943Ordine di trasferimento in Germania degli stabilimenti DucatiMessi sotto controllo commissariale durante la guerra e destinati alla produzione bellica, gli stabilimenti Ducati, che arrivano ad occupare circa 7.000 operai nel 1943, ricevono l'ordine di trasferimento (Befehl) a Rosenheim in Germania. E' minacciata la deportazione delle maestranze dallo stabilimento di Borgo Panigale (1.000 dipendenti residui) e dalle fabbriche decentrate di Bazzano (1.400 addetti per costruzioni radiotecniche) e Crespellano (1.500 addetti per impianti fluidotecnici) e la dispersione di attrezzature uniche al mondo. La sezione micromeccanica e tecnica di Borgo Panigale (circa 600 lavoratori e 200 macchine) è collocata per ordine del comando tedesco a Crevalcore, dentro lo stabile dell'Istituto professionale “Marcello Malpighi” e nell'ammasso canapa. Vi si progettano “dispositivi per la produzione in serie di pezzi per macchine da guerra segrete”. Il trasferimento di altre sezioni è in parte scongiurato da decentramenti parziali in località della provincia e in paesi del Nord Italia (Daiano, Longare, Albizzate, Parona di Valpolicella, Saronno, Pianezza), mentre una parte delle macchine e delle materie prime sono trasportate in diversi nascondigli a Bologna. Intanto la gamma dei prodotti Ducati si estende: dagli apparecchi trasmittenti agli strumenti ottici per la Marina, dalle spolette per bombe ai binocoli prismatici, dai telecomandi e alle pompe dei motori per aerei alle stazioni telegrafiche. I fratelli Ducati in parte collaborano con gli occupanti tedeschi - Bruno rischierà per questo la fucilazione nel primo dopoguerra - in parte lavorano per assicurarsi nuovi progetti e prodotti per il tempo di pace. Ad esempio, nella colonia comunale di Daiano, nei pressi di Cavalese (TN), il gruppo ottico, che produce per i Tedeschi il binocolo “Bimar”, costruisce anche il piccolo proiettore “Gioia” per uso scolastico. Nell'autunno 1944, alcuni dirigenti Ducati si recheranno a Firenze per assicurarsi la collaborazione dei migliori tecnici della Galileo e della San Giorgio. Qui sarà studiata una microcamera fotografica di alta classe, chiamata “Sogno”. A Bologna sarà fondata la REOM, diretta dall'antifascista Frati, per la ricerca in campo radioelettrico. Verranno inoltre attivati una settantina di laboratori speciali segreti, chiamati Post. Da qui usciranno i prodotti radio-elettro-ottico-meccanici che la Ducati sarà in grado di lanciare sul mercato già dalla Fiera di Milano del 1946, come il “Cucciolo”, piccolo motore a scoppio da 48 cc, studiato a Milano, in locali di fortuna, dagli ingegneri Rosi e Di Stefani.dettagli
-
27 settembre 1943Il Palazzo della Mercanzia semidistrutto da una bomba“Hostium rabies diruit”. (da un francobollo della RSI) Un sottufficiale tedesco fa brillare una bomba di aereo caduta nei pressi del portico del Palazzo della Mercanzia e rimasta inesplosa, nonostante il parere contrario di molti. Il lato orientale dell’antico edificio viene distrutto quasi completamente. I lavori di ripristino, celebrati dal regime con un francobollo celebrativo, saranno effettuati nel maggio 1944, in piena guerra, dal Genio Civile e completati tra il 1946 e il 1948 dalla Soprintendenza ai monumenti guidata da Alfredo Barbacci (1896-1989).dettagli
-
29 settembre 1943Sostituzione del comando tedescoIl comando della piazza di Bologna (Platzkommandantur) è affidato il 29 settembre al colonnello Helmuth Dannehl. Il precedente comandante, il tenente colonnello Kenda, austriaco e fanatico seguace di Mussolini, è trasferito ad altra sede. Con lui lascia la città il consigliere Fritz Lessing fiduciario del gruppo nazional-socialista locale. Il 10 ottobre sarà annunciata la costituzione del comando militare tedesco per la provincia di Bologna (Militarkommandatur). La sostituzione di ufficiali filo-fascisti con altri totalmente hitleriani ha il significato di una presa di distanza dalle strategie di potere dei fascisti della RSI. I Tedeschi preferiranno sempre l'appoggio dei "vecchi" gerarchi. A fine ottobre il comando del XIV Corpo d'Armata corazzato sarà fissato dapprima a Vedrana di Budrio, poi a Baricella e infine a Padulle di Sala Bolognese. Il generale von Senger und Etterlin, responsabile per ordine di Kesselring della zona d'operazioni, si appoggerà agli esponenti più moderati del fascismo bolognese - il podestà Agnoli, il capo della provincia Fantozzi - e sarà invece in drammatico contrasto con la GNR, le brigate nere e la polizia locale.dettagli
-
1 ottobre 1943La missione di Radio "Bologna Libertà"Alcuni giorni dopo l'armistizio parte da Bologna una missione, che dispone di una radio clandestina: “Bologna Libertà”. Ne fanno parte il medico Pino Beltrame (1910-1967), lo scrittore Antonio Meluschi (1909-1977), l'ing. Pasquini, costruttore dell'apparecchio trasmittente, Giuseppe Landi di Medicina, Augusto Bianchi e il prof. Amilcare Mattioli (Michi) di Casola Valsenio. La prima trasmissione è effettuata dalla villa di Beltrame vicino a Ferrara, poi da molte altre zone della Romagna. Per non essere individuato, infatti, il gruppo si sposta continuamente con un camioncino, che porta l'iscrizione "Pelli, conigli, uova, galline". L'apparecchio è nascosto sotto un cumulo maleodorante di pelli di coniglio. I messaggi della radio invitano i contadini a non farsi razziare il bestiame e il raccolto dai tedeschi e incitano alla resistenza.dettagli
-
1 ottobre 1943I rifugi e la protezione antiaereaDopo i primi bombardamenti alleati sulla città, l'Amministrazione comunale si adopera ad accrescere il numero dei rifugi antiaerei, investendo quasi tutto il denaro disponibile nella costruzione di ricoveri in galleria. Già il 2 luglio il podestà Ferné aveva inviato una lettera all'Ufficio Tecnico, affinchè i lavori di sistemazionie procedessero a ritmo intenso anche nei giorni festivi, con la consapevolezza che l'ultimazione di un ricovero anti bomba poteva significare "la salvezza di migliaia di vite umane". Ai rifugi anticrollo ricavati in cantine, sottopassaggi e gallerie ferroviarie, capaci, al 1° ottobre 1943, di proteggere solo 26.000 persone (l'8 per cento dei bolognesi presenti in città), si aggiungeranno le gallerie pedemontane, aumentando la capienza complessiva a 100.000 persone. Saranno 25 i rifugi in galleria alla fine della guerra (di cui 13 comunali), la maggior parte scavati sotto le colline, altri sotto i principali rilievi centrali, come la Montagnola, il monumento a Carducci, il Guasto dei Bentivoglio. I rifugi anticrollo in galleria diventeranno spesso alloggi permanenti per anziani e sinistrati: "Brandine, pagliericci, piccoli mobili salvati dalle macerie, suppellettili consunte dall'uso, immagini di santi contrassegnano i miseri acquartieramenti di intere famiglie" (Vianelli). I segnali di allarme o di limitato pericolo sono lanciati con le sirene da un'unica centrale situata in un primo tempo nel palazzo del Comando dell'esercito in via Galliera, in seguito sotto la torre coronata in via S. Alò. Un servizio di avvistamento e segnalazione delle zone colpite è organizzato sulla cima della torre Asinelli dall'ingegnere Luigi Marmocchi, con l'aiuto di alcuni volonterosi tecnici comunali. Il soccorso alla popolazione dopo le incursioni è affidato all'U.N.P.A. - Unione Nazionale Protezione Antiaerea, costituita nel maggio 1936 - e ai Vigili del Fuoco, mentre lo sgombero delle macerie è compito del Genio Civile. L'U.N.P.A., che condivide con il PFR un edificio in via Gandino 3, disloca numerose squadre di protezione in scuole periferiche, quali la "Mattiuzzi Casali" in via Azzurra e la "Tambroni" in via Toscana. I dispositivi di salvaguardia dei singoli palazzi sono sotto il controllo di un capo fabbricato, fiduciario nominato dal Partito Nazionale Fascista e dall’U.N.P.A., che si cura della chiusura delle porte dalle 23 alle 6 del mattino, salvo socchiuderle in caso di allarme aereo. Sono di sua competenza anche le condizioni igieniche e di sicurezza dei rifugi. Cura inoltre che tutti gli abitanti del caseggiato siano al riparo durante i bombardamenti. Tra i lavori comandati dalle autorità comunali o dai comandi tedeschi, particolarmente rischioso è quello di sentinella stradale antiaerea sulle principali arterie di transito. I precettati devono stazionare al loro posto e possono rifugiarsi nelle buche di protezione solo nel corso di un mitragliamento o di un bombardamento, lasciando nei pressi una bandiera di segnalazione.dettagli
-
5 ottobre 1943Le Fortezze Volanti attaccano Bologna124 fortezze volanti, appartenenti a varie formazioni del 5. Stormo dell'aviazione USA, attaccano Bologna tra le 11 e le 13, lasciando cadere circa 1.500 bombe da 500 libbre (365 tonnellate di esplosivo). Vengono colpiti quartieri rimasti indenni durante le incursioni precedenti, come la Cirenaica, e zone in prossimità delle linee ferroviarie fuori porta San Felice e porta Lame. Gravissimi sono i danni patiti dalla chiesa del Corpus Domini in via Tagliapietre, quasi del tutto distrutta. Sfondata la volta, rimangono in piedi solo i muri perimetrali. Va perduto il soffitto decorato dal Franceschini con l'apoteosi di S. Caterina de' Vigri. Molto danneggiati sono la sede del “Resto del Carlino” in via Dogali, il mercato ortofrutticolo e lo zuccherificio, gli alberghi Bologna e Astoria. E' gravemente lesionata la chiesa del Sacro Cuore dei padri Salesiani, la chiesa di San Giorgio in via Nazario Sauro e quella di San Martino. La stazione centrale è bombardata a tappeto: oltre mille viaggiatori trovano riparo nei sottopassaggi. Da questo momento lo scalo bolognese rimarrà inutilizzabile fino alla Liberazione. Nonostante l'impressionante violenza del bombardamento, il numero delle vittime civili non è così elevato come nell'incursione del 25 settembre: “solo” una ottantina di morti e altrettanti feriti. Molti sinistrati sono accolti dalla Curia a Villa Revedin, ma i più preferiscono fuggire dalla città. La casa di vacanze di Mussolini a Riccione ospiterà 80 bolognesi sfollati. Il 10 ottobre 300 parrocchiani del Pontevecchio, assieme al parroco don Mezzetti, sottoscriveranno un voto, promettendo l'erezione di un tempio in onore di Santa Teresa e chiederanno di essere preservati "da gravi distruzioni per incursioni aeree, e dagli orrori e devastazioni dei combattimenti". La chiesa votiva sarà realizzata nel dopoguerra su progetto dell'arch. Renato Sabbi e consacrata nel 1988.dettagli
-
7 ottobre 1943Apertura del lager delle Caserme RosseEntra in funzione il campo di transito e smistamento delle Caserme Rosse di via Corticella. Si tratta di un complesso di edifici in aperta campagna costruiti prima della guerra e destinati ad ospitare una scuola per ufficiali della Sanità. Tra i primi ad essere ospitati in questo lager sono i carabinieri di stanza a Roma che il 25 luglio 1943 hanno arrestato Mussolini per ordine del re e successivamente si sono rifiutati di partecipare al rastrellamento del ghetto ebraico della capitale. Il 7 ottobre sono stati disarmati per ordine del maresciallo Graziani e avviati alla deportazione in Germania rinchiusi in vagoni piombati, 40 prigionieri in ciascuno. A Bologna vengono fatti scendere in fretta “per fare i bisogni corporali”. Le Caserme Rosse ospitano i prigionieri razziati durante i rastrellamenti dell'esercito tedesco, soprattutto nelle città e sull'Appennino toscano ed emiliano. Nel solo periodo tra giugno e ottobre 1944 vi transitano circa 35.000 prigionieri. Nel campo, sorvegliato da soldati tedeschi e repubblichini, è effettuata una visita medica decisiva ai fini dell'assegnazione al lavoro nel Reich - spesso nei lager da cui pochi ritorneranno - o al lavoro sul fronte italiano al servizio dell'Organizzazione Todt e della Wehrmacht. Solo una piccola parte di prigionieri, per età o per malattia, possono essere dichiarati inabili. L'equipe medica del dottor Antonio De Biase (Delfini, n. 1909) tenta in ogni modo di evitare ai prigionieri le destinazioni più dure. Intanto diverse organizzazioni caritative si impegnano per alleviare le sofferenze dei rastrellati e rifugiare coloro che riescono a scappare durante i trasferimenti o nella confusione dei bombardamenti: dalla Pro.Ra. di don Giulio Salmi, alla Croce Rossa. Molti fuggiaschi si nasconderanno presso le famiglie contadine o presso gli ospedali e i conventi di Bologna. Anche il podestà fascista, l'ing. Mario Agnoli, si impegnerà nella protezione e nell'accoglienza dei rastrellati presso le strutture assistenziali cittadine. Le Caserme Rosse saranno anche luogo di fucilazioni e soppressioni di prigionieri. Dopo la guerra nell'area saranno rinvenute tracce di 16 fosse comuni.dettagli
-
7 ottobre 1943Tentativo di coinvolgere Arpinati nella Repubblica SocialeIn un incontro alla Rocca delle Caminate, promosso dal commissario federale del partito fascista repubblicano Aristide Sarti, dal direttore del “Carlino” Giorgio Pini e dal prorettore Goffredo Coppola, Benito Mussolini offre a Leandro Arpinati, vecchio ras di Bologna da tempo emarginato, l'incarico di ministro degli Interni nella neonata Repubblica Sociale Italiana, con la promessa di eleggerlo Presidente del Consiglio al termine della guerra. Arpinati, ormai lontano dal fascismo e in contatto con ambienti politici liberali moderati, declina l'invito, dichiarando il suo interesse esclusivo per l'agricoltura. Durante il colloquio il Duce gli confessa di voler strappare a Hitler il consenso per l'armistizio con gli anglo-americani, ma egli si mantiene freddo e distante, accusandolo di essere ormai prigioniero dei Tedeschi. L'esito negativo del colloquio sconvolge i piani “dell'ala più autorevole del fascismo bolognese” (Bergonzini) e porterà al repentino declino della carriera politica del giovane Sarti.dettagli
-
8 ottobre 1943I partigiani romagnoli a Pieve di RivoschioNell'ottobre del 1943 il Partito Comunista avvia la lotta armata in Romagna, impegnando Antonio Carini (Orsi), membro del Comando generale delle Brigate Garibaldi. Alcuni ex combattenti delle brigate internazionali in Spagna insediano nella sede del dopolavoro di Pieve di Rivoschio, frazione di Sarsina sull'Appennino a 600 metri s.l.m., la prima base partigiana nel territorio di Cesena. Per organizzarla si avvalgono di alcuni giovani del luogo. A fine mese la base conta quaranta partigiani divisi in quattro squadre, che iniziano a operare contro i nazifascisti. Si tratta di ragazzi di Ravenna e Cesena e soldati slavi fuggiti dal campo di prigionia di Renicci, nei pressi di Sansepolcro (AR), coordinati da Salvatore Auria (Giulio), un ex confinato politico di origine siciliana. La prima azione, il 1° novembre, è il disarmo di due guardie forestali effettuato dalla squadra di Albo Sansovini (Dik), mentre il 4 novembre a Sarsina è attaccata senza successo la caserma dei carabinieri. L'attività partigiana, divenuta presto intensa, porta il 16 novembre a un rastrellamento tedesco: 23 persone vengono arrestate e rinchiuse nel carcere di Forlì. Saranno tutte rilasciate nelle settimane successive, tranne il parroco don Pietro Paternò, considerato un collaboratore dei partigiani, che il 6 dicembre sarà trasferito a Bologna nel carcere di San Giovanni in Monte e di qui sarà avviato al lager tedesco di Dachau. Rientrerà in Italia nel giugno del 1945 ormai minato nel fisico e morirà pochi mesi dopo. A fine novembre i partigiani lasceranno Pieve di Rivoschio, trovando rifugio dapprima nel podere Collinaccia a Galeata, poi sopra Santa Sofia, tra Stabatenza e Ridracoli, infine nella zona di Pian del Grado. La formazione sarà posta sotto il comando di Riccardo Fedel (Libero) e divisa in due compagnie. L'8a Brigata Garibaldi tornerà a Campofiore di Pieve di Rivoschio nel giugno 1944. I partigiani colpiranno ripetutamente il nemico e insidieranno strade di vitale importanza per la Wehrmacht. In un rapporto del comando sarà scritto che le loro azioni "gli rendono le spalle mal sicure, i traffici difficili e lo obbligano a presidiare ponti, strade e località distogliendo migliaia di soldati che altrimenti potrebbe impiegare al fronte". L'area sarà inevitabilmente soggetta a sanguinose rappresaglie e a frequenti rastrellamenti, soprattutto quello del 20 agosto, che terminerà con la strage della fornace di Meldola. All'inizio di ottobre nei dintorni di Pieve si svolgerà una dura battaglia tra i partigiani e i Tedeschi in ritirata dalla Linea Verde I.dettagli
-
17 ottobre 1943Arresto dell'ex Podestà Angelo ManaresiL'ex podestà di Bologna ed ex deputato Angelo Manaresi (1890-1965) viene arrestato dalla Milizia su denuncia di Enrico Cacciari e rinchiuso nel carcere di San Giovanni in Monte. Pluridecorato della grande guerra ed ex presidente dell'Opera nazionale combattenti, al momento della caduta del regime era ispettore nazionale del PNF. Dopo il 25 luglio, in qualità di comandante del X reggimento Alpini e di presidente dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), ha inviato un telegramma di appoggio al Re e a Badoglio. E' quindi considerato un traditore dagli oltranzisti della RSI. Verrà liberato in dicembre per ordine di Mussolini.dettagli
-
23 ottobre 1943Il tenente pilota Ugo Bassi muore in JugoslaviaIl tenente pilota Ugo Bassi muore durante una missione in Jugoslavia. Dopo aver partecipato a un mitragliamento nei pressi di Podgorica, dove è stato colpito il capitano Ottaviano, sulla via del ritorno è intercettato da due caccia tedeschi Me 109, che lo attaccano da quota superiore. Il suo aereo si schianta al suolo, senza che egli possa salvarsi. Il giorno prima il 5° Stormo della Regia Aeronautica, divenuta dopo l'armistizio dell'8 settembre forza armata cobelligerante, era stato passato in rassegna dal Re all'aeroporto di Manduria, nei pressi di Taranto. Il tenente Bassi pilotava un caccia bombardiere Reggiane Re.2002 “Ariete”, uno degli aerei reduci dai combattimenti dell'estate contro gli sbarchi alleati. Il nome di Ugo Bassi è anche in un elenco di sette ufficiali italiani catturati dai tedeschi il 23 ottobre 1943 a Pogradec, durante un rastrellamento della divisione “Brandeburgo”, e fucilati il 24 ottobre 1943 (M. Parigi).dettagli
-
23 ottobre 1943A caccia di una preziosa "borsa tattica"Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre all’Albergo Alta Romagna di Santa Sofia (FC) un ufficiale tedesco del genio viene ferito gravemente da una banda di partigiani. L’azione - il primo agguato alle forze armate tedesche registrato nell’Appennino romagnolo - fa grande scalpore in tutta la regione e viene menzionata anche da Radio Londra. I “ribelli”, guidati da Enrico Ferro (Tenente), ex ufficiale dell’esercito, provengono da una base stabilita nei pressi di Premilcuore. Il loro obiettivo è impossessarsi di una borsa di pelle, che si ritiene contenga un primo abbozzo della Linea Gotica attorno all’Alpe della Luna e fino al passo del Muraglione. I documenti trafugati sono portati da Ferro al notaio Virgilio Neri (1906-1982) di Faenza, componente del Comitato Romagnolo di Resistenza, che coordina l'attività partigiana in Romagna. Egli a sua volta li farà avere a due emissari di Ferruccio Parri (1890-1981) provenienti da Milano, incaricati di consegnarli agli Alleati.dettagli
-
28 ottobre 1943Prima adunata del Fascio RepubblicanoNel maneggio di via Gandino si tiene la prima adunata del Fascio Repubblicano di Bologna, ricostituito il 19 settembre. E' approvato un ordine del giorno del prof. Goffredo Coppola (1898-1945) in cui si chiede la condanna a morte del re e di molti capi politici del periodo badogliano. Si reclama inoltre il sequestro dei beni e la confisca delle proprietà agricole del gerarca traditore Dino Grandi (1895-1988), autore dell’ordine del giorno che ha provocato la caduta di Mussolini e del fascismo il 25 luglio 1943.dettagli
-
novembre 1943I bunker di MesolaA Mesola, località a nord di Ravenna sul margine meridionale del delta del Po, tra l'inverno del 1943 e la primavera del 1944, i tedeschi realizzano, tramite la Todt, il più imponente sbarramento difensivo sul suolo italiano. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, Hitler teme un secondo sbarco in Adriatico oltre gli Appennini. Viene quindi decisa una linea difensiva tra Bologna e Comacchio, appoggiata sui canali e le valli allagate del Delta. Chiamata in un primo tempo “Reno Stellung”, diventerà poi “Dschingis Khan Stellung” (linea Gengis Khan). Quella di Mesola non è una linea antisbarchi di fronte al mare, ma una zona di difesa profonda quattro chilometri nell'entroterra lungo la via Romea. A nord di Bosco Mesola la strada, protetta a sinistra dalle acque della palude “La Vallona”, all'improvviso gira a destra e realizza una sorta di imbuto attorno al Gorgo del fondo: questo diviene il punto strategico per bloccare un eventuale attacco alleato verso Venezia. Nell'area di Mesola vengono costruiti trenta bunker, alcuni dei quali in paese e la maggior parte nella pineta delle Motte e del Fondo. Essi non verranno, in realtà, mai armati: dopo lo sbarco alleato ad Anzio, la difesa tedesca si attesterà sulla Linea Gotica in Appennino e nella primavera del 1945 la zona del Po sarà oltrepassata dagli Alleati, con i tedeschi in rapida ritirata. Nel dopoguerra i bunker di Mesola, chiamati in gergo “i furtin”, saranno abitati dai civili, in alcuni casi fino agli anni Sessanta.dettagli
-
1 novembre 1943Prime bande di partigiani in AppenninoSui monti dell'alto Reno si formano le prime bande di partigiani, composte da militari disertori, sfollati, ex prigionieri, giovani in fuga dalle chiamate alle armi della RSI. Nel mese di ottobre un gruppo di antifascisti bolognesi, guidati da Libero Lossanti (1919-1944), sale nella zona di Vidiciatico con il proposito di stabilirvi una basa partigiana. Ai primi di novembre si forma in località La Cà, nei pressi di Lizzano in Belvedere, un primo nucleo di combattenti. Esso comprende, oltre a Lossanti, Adriano Brunelli, Monaldo Calari, Rino Gruppioni (Spartaco), Nerio Nannetti, Giancarlo Romagnoli. La formazione avrà vita molto breve: i "cittadini" hanno scarsa conoscenza del territorio, mancano i rifornimenti e i collegamenti con le altre bande di "ribelli" presenti in zona. Il 27 novembre la base di Cà Berna sarà identificata e tre partigiani verranno catturati. Tradotti a Bologna nelle carceri di San Giovanni in Monte, Giancarlo Romagnoli, Adriano Brunelli e Lino Formilli verranno fucilati al Poligono di tiro il 3 gennaio 1944. Una buona parte dei reduci di questo primo gruppo di bolognesi andrà a combattere in Veneto, mentre un'altra parte si rifugerà nella zona di Monte Capra, dove è presente da alcuni mesi un altro gruppo, composto di renitenti alla leva e comandato da Amleto Grazia (Marino). Dalla fusione delle due formazioni nascerà in seguito la 63a Brigata Bolero. Vita ancor più effimera ha il distaccamento partigiano "Carlo Pisacane", formatosi a metà novembre a Guiglia sull'Appennino modenese. A fine mese esso subirà un imponente rastrellamento tedesco, che costringerà i partigiani a ripiegare a Mongardino, prima di sciogliersi per varie destinazioni, tra il forlivese e il Veneto. Un terzo gruppo si radunerà sui monti a sud del bacino del Brasimone. Si tratta di patrioti imolesi armati di una mitragliatrice senza treppiede, cinque moschetti e venti bombe a mano. Il tentativo fallirà per le enormi difficoltà ambientali e di rifornimento. I partigiani di Castiglione dei Pepoli saranno inviati in Romagna, in località Albergo di Cortecchio sul monte Faggiola, dove tra il 10 e il 20 novembre si riunirà, in accordo con il CNL di Riolo Terme, il primo nucleo della futura 36a Brigata Garibaldi, formata soprattutto da combattenti imolesi. Sull'Appennino rimarranno piccoli gruppi destinati a consolidarsi la primavera successiva: la brigata pistoiese di Gino Bozzi a Poggiolforato, la banda di Alfredo Mattioli (Toscanino) a Monte Cavallo, la banda irregolare di Urio Nanni, quella di Renato Castelli (Toti) e di Ennio Farneti (Slit). Questi gruppi effettueranno azioni di sabotaggio e di intimidazione dei fascisti locali, operando spesso fuori dal controllo del CLN.dettagli
-
4 novembre 1943Sfilata silenziosa davanti al Bollettino della VittoriaNumerosi cittadini, in maggioranza donne, seguendo l'appello contenuto in un volantino del CLN, sfilano in silenzio davanti alla lapide con il Bollettino della Vittoria in piazza Nettuno. Alcuni, come Candia Onofri, depongono fiori sotto gli occhi degli agenti della polizia in borghese, a significare la volontà di insorgere contro i tedeschi e i fascisti.dettagli
-
4 novembre 1943Attentato gappista al ristorante "Il Fagiano"La sera del 4 novembre, presso il ristorante Il Fagiano in via Calcavinazzi, tre giovani partigiani - Vittorio Gombi (Libero), Libero Romagnoli (Gino) e Libero Baldi - compiono un attentato contro le truppe tedesche, ferendo tre militari con il lancio di una bomba a mano. Si tratta della prima azione cruenta in città della 7a GAP (Gruppi azione patriottica), un'azione improvvisata e decisa autonomamente dai tre ragazzi, a testimonianza di un'organizzazione della guerriglia ancora insufficiente. Per ritorsione il comando tedesco anticipa il coprifuoco alle 21, annuncia il fermo di dieci antifascisti come ostaggi e promette 50.000 lire a chi aiuta a catturare i colpevoli. Accusa inoltre di inefficienza la questura bolognese e pochi giorni dopo lo stesso questore sarà allontanato. La scarsa collaborazione della polizia bolognese con i tedeschi è riconosciuta anche da Arturo Colombi. Secondo il responsabile dell'attività militare del Partito comunista, dopo essere stata "una delle più malvagie contro gli antifascisti" nel Ventennio, dall'8 settembre essa si è comportata "con onestà e senso patriottico", addirittura avvertendo i partigiani nell'imminenza dei rastrellamenti.dettagli
-
7 novembre 1943Retata di ebrei da parte delle SSIl 16 ottobre i nazisti hanno rastrellato il ghetto di Roma e iniziato la deportazione di 2.091 cittadini di origine ebraica. Quasi tutti spariranno ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio tedeschi. Il 7 novembre ha inizio la prima retata di ebrei bolognesi da parte delle SS. L'Einsatzkommando Italien, costituito in ottobre con una decina di uomini, al comando del capitano Theodor Dannecker, ha il compito di catturare tutti gli ebrei nelle principali città italiane con azioni lampo e di spedirli subito in Germania. La caccia a Bologna va in parte a vuoto, nonostante i nazisti abbiano a disposizione un accurato elenco fornito dalla polizia italiana. Non riescono invece a procurarsi la lista della Comunità Israelitica, chiesta invano a Mario Finzi, il Delegato Assistenza Emigranti, che adduce come scusa il bombardamento della sinagoga. L'8 novembre i tedeschi prelevano dalla sala operatoria della sua clinica, Villa Bianca, il noto tisiologo Attalo Muggia, che sarà internato a Fossoli e poi deportato in Germania, dove scomparirà nel lager. La famiglia riesce invece a lasciare Bologna e a rifugiarsi da amici a Massa Lombarda e Cotignola. Una ventina di ebrei catturati - tra essi le famiglie Goldstaub, Bonacar, Pinto - vengono condotti nella sede delle SS, quindi alle Caserme Rosse (o forse alla caserma di artiglieria di Viale Panzacchi), dove vengono concentrati anche alcuni ebrei razziati a Siena. Il 9 novembre sono caricati insieme su un treno di prigionieri proveniente da Firenze, che il 14 giungerà ad Auschwitz.dettagli
-
7 novembre 1943Arresto del leader socialista Alberto TrebbiL'esponente antifascista Alberto Trebbi (1892–1975) viene arrestato e imprigionato nel carcere di San Giovanni in Monte. Ha aderito fin da ragazzo agli ideali socialisti e, nel settembre 1920, ha diretto la Fiom bolognese durante l’occupazione delle fabbriche. I fascisti lo hanno perseguitato per tutto il ventennio: bastonato più volte, assieme alla moglie Ellena Tannini, è stato arrestato nel 1925 e condannato al confino a Lipari per cinque anni. Per tutti gli anni Trenta ha continuato, nonostante la stretta sorveglianza della polizia, ad essere un punto di riferimento per l'organizzazione clandestina antifascista. Il suo negozio di calce e gesso in vicolo Broglio è uno dei centri più importanti della Resistenza in città. Dopo una lunga detenzione nel carcere bolognese e a Castelfranco Emilia, il 21 gennaio 1944 Trebbi sarà deportato nel lager tedesco di Dachau, da dove riuscirà a ritornare, ormai ridotto a 43 chili di peso, nel maggio 1945. Nel dopoguerra sarà presidente del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti di Bologna (ex Consorzio fra birocciai, carrettieri e affini) e della Cooperativa Fornaciai. Ricoprirà anche la carica di presidente provinciale dell'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti).dettagli
-
9 novembre 1943Bando di arruolamento della RSIIl 9 novembre viene emesso il primo bando di arruolamento per le forze armate della RSI. Riguarda le classi 1923, 1924 e 1925. Il manifesto avverte che le nuove reclute devono presentarsi ai distretti tra il 15 e il 30 novembre 1943, ad eccezione di coloro che lavorano come operai specializzati in aziende ausiliarie per la produzione bellica. "In caso di mancata presentazione dei militari soggetti alla predetta chiamata, oltre alle pene stabilite dalle vigenti disposizioni del codice militare di guerra, saranno presi immediati provvedimenti anche a carico dei capi famiglia" Per molti giovani è il momento di scegliere se entrare nelle unità militari fasciste, se nascondersi, oppure se raggiungere le formazioni della Resistenza, che già nel settembre 1943 contano 638 combattenti.dettagli
-
10 novembre 1943Il capo della Provincia chiede aiutiIl capo della Provincia Montani illustra, in una lettera a Mussolini, la situazione di Bologna dopo i tremendi bombardamenti dell'estate sulla città. Circa 6.000 famiglie risultano sinistrate. I rifugi casalinghi si sono rivelati inadeguati e vulnerabili. I rifugi pubblici possono ospitare meno di 30.000 persone. Lamentandosi della mancanza di aiuti dal governo, Montani chiede finanziamenti per la costruzione di rifugi pedecollinari in galleria in grado di ospitare "almeno 50.000 persone" e per l'edificazione di villaggi di baracche in periferia per i sinistrati e gli sfollati.dettagli
-
15 novembre 1943Eccidio del Castello Estense di FerraraNella notte tra il 13 e il 14 novembre viene ucciso il Federale di Ferrara Igino Ghisellini (1895-1943). Il suo corpo è ritrovato a Castello d'Argile, in provincia di Bologna, “fulminato da cinque colpi di pistola e privo degli stivali”. La notizia dell'attentato è portata a Verona, dove sono riuniti per il Congresso del Partito Fascista Repubblicano, assieme alle delegazioni delle altre città, anche i rappresentanti ferraresi. Questi ultimi rientrano rapidamente a Ferrara, inviati dal segretario Alessandro Pavolini (1903-1945), assieme a squadristi di Padova e Verona, per vendicare l'assassinio con una “spedizione punitiva” esemplare. Tre camion carichi di squadristi di Ferrara, Cento e Pieve di Cento invadono Castello d'Argile muniti di lanciafiamme e taniche di benzina, decisi a incendiare tutto il paese. La rappresaglia è sventata per l'intervento di Eolo Fagioli, autorevole fascista ferrarese residente a Castello e genero del Podestà locale. Nella notte del 14 novembre a Ferrara vengono arrestate 75 persone e ha inizio la rappresaglia. All'alba del giorno seguente undici cadaveri di antifascisti innocenti sono rinvenuti nei pressi del fossato del Castello e in altri luoghi della città. Quattro di essi sono ebrei. Il tragico evento ispirerà un racconto della raccolta Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani, da cui il regista Florestano Vancini trarrà, nel 1960, il film La lunga notte del '43. La morte di Ghisellini rimarrà un mistero: sarà addossata ad alcuni a partigiani comunisti provenienti da Bologna, mentre altre ricerche ipotizzeranno una faida interna al partito fascista.dettagli
-
23 novembre 1943Prima azione della brigata "Stella Rossa"I partigiani della Brigata Stella Rossa, formazione autonoma che opera nella val di Setta attorno alla ferrovia Direttissima, compiono la loro prima azione. Nei pressi di Grizzana fanno saltare un treno, distruggendo sei cisterne di benzina e quattro vagoni di automezzi. La Stella Rossa è la prima unità partigiana sorta dopo l'8 settembre in Emilia-Romagna. Tra l'ottobre e il novembre 1943 una ventina di uomini, tutti residenti nei comuni di Monzuno e Marzabotto, si riuniscono fra i boschi di San Nicolò e nella sacrestia della chiesa di Vado. Un importante ruolo di organizzazione e poi di collegamento con i primi combattenti alla macchia è svolto da Umberto Crisalidi (Il Vecchio), antifascista di vecchia data, assieme a Giorgio Ugolini e Guido Musolesi. Nel novembre 1943 Mario Musolesi (Lupo, 1914-1944), ex militare carrista, è scelto come comandante della formazione, che conta solidamente sull'appoggio delle famiglie residenti nella zona. La Stella Rossa sarà una spina nel fianco degli occupanti tedeschi, con sistematici attacchi ai convogli e sabotaggi delle linee ferroviarie. Il 28 gennaio una squadra attaccherà la caserma della milizia fascista di Monzuno, disarmando gli occupanti. La brigata subirà un primo grande rastrellamento nel maggio 1944 e sarà poi sgominata durante il grande eccidio di Monte Sole, nel settembre 1944.dettagli
-
24 novembre 1943Goffredo Coppola è il nuovo Rettore dell'Alma MaterDopo le brevissime reggenze, tra il 31 agosto e il 23 novembre, di Enrico Redenti, Umberto Borsi e Umberto Puppini, è nominato Rettore dell'Università Goffredo Coppola (1898-1945), professore di letteratura greca e latina all'Alma Mater dal 1932 e “uomo di trincea” del fascismo repubblicano. All'inizio egli sembra ottenere la fiducia delle autorità tedesche occupanti, anche per le sue posizioni ideologiche razziste e filo-naziste. Da anni pubblica sul "Resto del Carlino", "Il Popolo d'Italia" e "Il Corriere della Sera" articoli ferocemente antisemiti, che nel 1944 raccoglierà nel volume Trenta denari. Il suo primo provvedimento, approvato dal Senato accademico, nega agli studenti abili alle armi l'accesso alle lezioni, con l'asserzione che "la cultura si difende al fronte". Le lezioni devono essere regolari solo per i mutilati, "per le studentesse e gli ecclesiastici". La conseguenza è un crollo delle iscrizioni, da 14.000 a 5000. Nella seduta del Senato Accademico del 4 dicembre imporrà la denuncia per tradimento e la sospensione degli stipendi ai professori assenti da Bologna. Il suo intento di isolare l'Università e tenerla al riparo dal conflitto in atto si rivelerà ben presto una illusione.dettagli
-
27 novembre 1943Bombardamenti nella Valle del Reno. Colpite Vergato e la cartiera della LamaIl 27 novembre verso le 12,40 una formazione di bombardieri americani (15 fortezze volanti decollate a Pisa) sgancia alcune decine di bombe sull'abitato di Vergato. Non vengono colpiti i probabili obiettivi di questa missione, dichiarata “Pin Point Precision” (di massima precisione), cioè i ponti stradali e ferroviari sul Reno e il Vergatello, ma diverse abitazioni private. Si contano 46 morti e più di 200 feriti, soprattutto in un mulino in località America. I funerali delle vittime si terranno tre giorni dopo in forma solenne, alla presenza delle autorità comunali e di un rappresentante del Comune di Bologna. Lo stesso 27 novembre nella valle del Reno si hanno pesanti incursioni aeree anche a Pian di Setta, sul ponte e sulla canapiera di Pioppe di Salvaro, a Sasso. Lama di Reno è “devastata dal getto micidiale” : nella cartiera I.R.I.S. e nel paese accanto rimangono uccise 40 persone. Don Giovanni Fornasini, parroco di Sperticano (poi martire a Monte Sole) è tra i primi a soccorrere i feriti e a cercare le vittime tra le macerie.dettagli
-
27 novembre 1943Rapimento del reggente di Zocca e arresto di Zosimo MarinelliIl 27 novembre il reggente del fascio di Zocca Vincenzo Minelli si presenta con una squadra di camerati all’abitazione di Zosimo Marinelli, esponente dell’Azione Cattolica e oppositore del regime. Nato a Montombraro (o Monteombraro) da una famiglia di agricoltori, Zosimo ha partecipato alla grande guerra e quindi si è laureato in ingegneria. La direzione di una miniera di zolfo in Sicilia gli è stata tolta per il suo rifiuto ad iscriversi al Pnf. Dopo la caduta del fascismo ha attivato contatti con esponenti del Partito d’Azione bolognese e dopo l’8 settembre si è impegnato a sostenere la renitenza dei giovani ai bandi di arruolamento della RSI. All’intimazione dei fascisti che vanno ad arrestarlo accorrono in suo aiuto alcuni partigiani azionisti nascosti in una macchia di bosco vicino alla sua villa. Gli aggressori si danno alla fuga, ma il reggente Minelli viene catturato e più tardi fatto sparire. Marinelli si allontana con la famiglia da Montombraro. Come reazione alla cattura del reggente, i fascisti di Modena organizzano una spedizione punitiva guidata dal commissario federale Giovanni Tarabini Castellani. La villa di Marinelli viene devastata. Sono arrestate un centinaio di persone, tra le quali la moglie e le tre figlie di Zosimo. Dopo un mese di latitanza l’ingegnere è arrestato dai carabinieri di Zocca. Secondo un’altra versione si presenta spontaneamente per salvare la sua famiglia. Il 27 gennaio 1944 sarà condotto al Poligono di Tiro di Bologna assieme a nove compagni e fucilato, dopo un processo-farsa, dalla banda del famigerato Tartarotti, per vendicare l’uccisione del federale di Bologna Eugenio Facchini da parte di alcuni gappisti. Prima di morire scriverà un’ultima lettera alla moglie: "Il Tribunale ha pronunciato la mia sentenza di morte, ma sono tranquillo. Fa' che i miei figli siano onesti come quegli che se ne va a Dio. Ho perdonato e perdono tutti quelli che volontariamente o involontariamente hanno procurato a me questo estremo passo. Nessuno cerchi né pensi a vendetta, ma si pensi e si chieda a Dio la rassegnazione, la pace". Ai figli chiederà di "amare la chiesa, la famiglia, la terra che ho tanto amato" e li solleciterà ad aiutare i poveri "ravvisando nel loro volto il volto rattristato di Cristo”. Nel 2009 il Presidente della Repubblica Napolitano assegnerà a Zosimo Marinelli la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria (motivazione).dettagli
-
28 novembre 1943I Gruppi di difesa della donna (GDD)Cinque donne appartenenti all'antifascismo - Ada Gobetti, Giovanna Barcellona, Lina Fibbi, Lina Merlin, Rina Piccolato - promuovono, con un documento programmatico, i Gruppi di difesa della donna (GDD), aperti alle donne disposte a sostenere ed assistere i partigiani, gli antifascisti, i rastrellati. Fogli dattiloscritti come "Noi donne" e "La voce delle donne" contengono incitamenti alla lotta sociale e politica e proposte di rivendicazioni, quali gli alloggi per i sinistrati, il riscaldamento nelle scuole, migliori razioni alimentari. Nel giugno 1944 il CLNAI riconoscerà i GDD come "organizzazione aderente al Comitato di liberazione nazionale". In ottobre sarà riconosciuto anche il Comitato bolognese, operativo fino dal febbraio precedente e diretto da Vittoria Guadagnini (Dina), di cui fanno parte Liliana Alvisi (1915-2005), Novella Corazza (Vera), Diana Franceschi e Vittorina Tarozzi (Gianna). La Alvisi, giovane medico proveniente da una famiglia tenacemente antifascista, si incaricherà di raccogliere materiale sanitario per il movimento partigiano e svolgerà brevi corsi pratici di pronto soccorso per le staffette destinate alle brigate della montagna. Il suo ambulatorio al Pontevecchio sarà luogo di incontro per i medici e i sanitari vicini alla Resistenza. Dopo la Liberazione, i Gruppi di difesa della donna confluiranno nell'UDI (Unione Donne Italiane).dettagli
-
dicembre 1943Agitazioni operaie e azioni di resistenza alle Officine RizzoliGli operai delle Officine Rizzoli entrano in agitazione per sventare la minacciata abolizione dell’indennità giornaliera di 10 lire da parte dell’azienda. E’ avanzata una piattaforma rivendicativa, che sarà poi ripresa dagli operai di altre fabbriche bolognesi. Essa prevede tra l’altro: un aumento del salario, una razione giornaliera di 500 gr di pane, la consegna di legna e carbone per il riscaldamento, mezzo litro di latte per i figli dei dipendenti, la cessazione dei licenziamenti arbitrari. Dopo l'8 settembre, in una palazzina delle Officine, si è installato il comando delle Brigate Nere. I materiali e i macchinari destinati alla fabbricazione delle protesi ortopediche cominciano presto a interessare anche i tedeschi. Per evitare requisizioni la direzione dispone di nasconderli in camere chiuse dell'Ospedale Sant'Orsola e dentro la cappella dell'Istituto di Rieducazione del Pratello. I materiali di valore, ad esempio il bronzo, sono nascosti nei sotterranei della chiesa di San Michele in Bosco. Nelle Officine opera un gruppo in rappresentanza del CLN - Aniceto Servisi, Umberto Fontana, Dante Lorenzini - che si adopera nella raccolta di fondi per il movimento partigiano. I licenziamenti degli operai saranno scongiurati fino alla fine della guerra. Negli ultimi mesi dell'occupazione i dipendenti saranno utilizzati nei più vari impieghi: dallo sgombero delle macerie di edifici bombardati al taglio degli alberi della via Panoramica.dettagli
-
dicembre 1943Riconversione delle industrie alla produzione bellicaAlla fine del 1943 le industrie meccaniche bolognesi hanno convertito la maggior parte della loro produzioni per usi bellici. Sono controllate dal Commissariato generale fabbricazioni di guerra (Cogefag o “fabbriguerra”) e divise in quattro grandi rami produttivi: auto e moto, macchine operatrici, settori radiotecnico e elettromeccanico. La Calzoni fa apparecchi idrodinamici per i comandi della marina e dell'aeronautica e carri armati per l'esercito. La Sabiem fa serie complete di parti per obici, la Sasib affusti di cannone, piastre d'acciaio del cannone anticarro 47-32, meccanismi di puntamento e bossoli. Inoltre fa revisione di motori d'aereo nella sezione Avio, distaccata a Meldola (FO). L'ACMA fa parti di siluri, di motori per aviazione e di armi. La B.B. fabbrica candele, l'ALMA le rigenera. La Weber produrrà al 90% carburatori per l'esercito tedesco. A Casaralta si costruiscono veicoli ferroviari di ogni tipo, alla G.D parti della mitragliera Breda, alla Cevolani parti di armi e di motori aerei. Oltre che stazioni e apparecchi radio per l'esercito, la Ducati produrrà per i tedeschi pompe per motori, condensatori, apparecchi ottici, parti di armi e motori di aerei. L'azienda ha già provveduto tra il 1942 e il 1943 a dislocare una buona parte della produzione a Crespellano e a Bazzano. Nella sede distaccata di Crespellano saranno costruiti pezzi di ricambio per i micidiali caccia tedeschi Stukas. Lo stabilimento di Bazzano verrà costruito in tempi record e arriverà ad occupare circa 800 operai nella produzione di pompe speciali per motori d’aereo. La ditta Baschieri e Pellagri di Marano, nota come “la polveriera di Castenaso”, è specializzata nel caricamento dei proiettili, attività di riuso dei residuati bellici. Ha circa 600 addetti alla fine del 1943, quando viene sfollata a Farneto. Altre officine impegnate nella produzione bellica sono la Buini & Grandi, che fa impianti per aeroporti, la Filotecnica (orizzonti artificiali), Babini (cerniere metalliche), Cevolani (ricambi), FIM (radiatori), SIAP (strumenti di assistenza al volo). La Minganti produce fresatrici per carter motori, mentre Morini fa bilancieri per valvole. Nelle fabbriche impegnate nella produzione militare l'occupazione si espanderà soprattutto durante i primi anni del conflitto. Ad esempio la Curtisa raggiungerà i 400 dipendenti, la Minganti da 600 persone nel 1938 passerà a 1.550 nel 1941, la Calzoni impiegherà fino a 1.600 operai in turni continui. A seguito dei bombardamenti aerei dell'autunno 1943 molti stabilimenti trasferiscono i macchinari in casolari di campagna, ma anche in palazzi storici del centro. L'ACMA, ad esempio, trova sede a San Lazzaro, in un edificio di proprietà del suo amministratore unico Gaetano Barbieri. La Società Poligrafica "Il Resto del Carlino" si sposta a Lavino di Mezzo, l'OMSA tenta senza successo di andare a Pianoro. Alcuni opifici subiscono gravi danni già dopo le prime incursioni, come la FIM di via Mascarella, distrutta durante il tragico bombardamento del 25 settembre 1943 o la Sabiem & Parenti, colpita il 5 ottobre. Nel dicembre del 1943 l'occupazione nelle fabbriche bolognesi risulta in calo, per i ripetuti bombardamenti, per la presenza dell'occupante tedesco e per la grave crisi alimentare in atto.dettagli
-
1 dicembre 1943Ordine di rastrellamento degli ebrei e sequesto dei loro beniIn applicazione alle disposizioni della Carta di Verona della RSI, dove si enuncia che “gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri e appartengono a nazionalità nemica”, e in base all'ordinanza di polizia n. 5, emessa il 30 novembre dal Ministro degli Interni Buffarini Guidi, il Capo della provincia Montani ordina di rastrellare tutti gli ebrei e avviarli “in appositi campi di concentramento”, disponendo inoltre il sequestro dei loro beni mobili e immobili. Un articolo del "Resto del Carlino", pubblicato il 2 dicembre con il titolo Fino in fondo, dichiara che i gli ebrei sono elementi pericolosi sia nel campo economico, che in quello politico, culturale e morale. Essi sono colpevoli di tutte le crisi, le guerre e le sciagure del mondo, sono "istintivamante nemici" del paese che li ospita. Disposizioni successive prevederanno la sistemazione provvisoria degli arrestati in caserme e scuole, in attesa dell'allestimento del campo di Fossoli, in provincia di Modena. Alcune deroghe alle misure di internamento resteranno in vigore fino al febbraio 1944: dopo di allora gli ebrei saranno arrestati e deportati senza alcuna distinzione, compresi i vecchi, gli ammalati. I "misti" saranno ancora per qualche mese trattenuti a Fossoli e deportati in agosto, alla chiusura del campo. La cattura degli ebrei, da parte della polizia italiana e nazista, verrà ostacolata dalle iniziative di protezione messe in atto da organizzazioni antifasciste, come quella guidata da Mario Jacchia, Armando Quadri e Gino Onofri. Esse riusciranno in molti casi a dotare i ricercati di documenti di identità falsi, intestati a persone residenti nelle zone liberate. Intere famiglie troveranno rifugio in località isolate dell'Appennino, come Riola di Vergato o in alcuni paesi della Romagna, come Cotignola e Massa Lombarda, a volte sotto la protezione di amici "ariani". Degli oltre 800 ebrei residenti in città, 114 troveranno la morte nei campi di sterminio tedeschi. Tra essi il Rabbino Leone Alberto Orvieto, per 44 anni alla guida della comunità israelitica bolognese, che sarà deportato assieme alla moglie Margherita Cantoni. La maggior parte degli oltre 70 ebrei arrestati a Bologna saranno vittime dell'apparato repressivo fascista: solo quattro, infatti, saranno catturati direttamente dai tedeschi. Alcuni giovani ebrei parteciperanno attivamente alla Resistenza: tra essi Franco Cesana (1931-1944), il più giovane partigiano d'Italia (Medaglia di bronzo al VM alla memoria).dettagli
-
3 dicembre 1943La diffusione dei giornali radio è obbligatoriaIl Capo della provincia rende obbligatorio il funzionamento della radio nei pubblici esercizi per l'ascolto dei notiziari (Giornali radio). Per i gestori che trasgrediscono è previsto il ritiro della licenza.dettagli
-
5 dicembre 1943Ebrei catturati a Riolo Terme. Moriranno ad AuschwitzAlcuni ebrei rifugiati a Riolo Terme (RA) vengono catturati il 5 dicembre durante un rastrellamento. Tra essi i membri della famiglia Piazza - Angelo di 68 anni, la moglie Margherita (67) e la figlia Maria Luisa (34) - residente a Bologna in via Indipendenza. Dapprima rinchiusi nelle carceri di Ravenna, i prigionieri verranno poi trasferiti a Milano a San Vittore il 30 gennaio 1944. Saranno infine sterminati nel lager di Auschwitz il 6 febbraio successivo. Una lapide a Riolo ricorda la loro triste sorte, assieme alle famiglie "che diedero loro generoso rifugio" e alla Brigata Ebraica, che il 27 marzo 1945 contribuirà alla liberazione del paese romagnolo.dettagli
-
7 dicembre 1943Violazioni alle disposizioni annonarie e frodi alimentariAlcuni ristoranti del centro cittadino vengono chiusi provvisoriamente per violazione delle disposizioni annonarie. Non è che la superficie di una vasta realtà di speculazione organizzata, con giganteschi accaparramenti e frodi alimentari incontrollate, che provocano smisurati arricchimenti. Nel gennaio 1941 un gruppo numeroso di accaparratori di caffè e zucchero sono scoperti e arrestati. Sette droghieri vengono denunciati per frodi annonarie. Si spaccia lana fatta con residui del latte, mentre quella buona, raccolta nelle scuole per i soldati al fronte, finisce in magazzini particolari. Le contraffazioni sono decine: dalla cioccolata fatta con farina di castagne, ai copertoni di gomma autarchica, che si sfaldano pochi giorni dopo l'uso. Si confeziona il “pane del Negus”, di colore nero, perché ricavato dai semi degli acini d'uva. Ci sono intrugli vegetali dai nomi fantasiosi: Vegetina, Exovol, Conditutto. Intanto in ristoranti simili a quelli multati ospiti “speciali” possono banchettare dopo il coprifuoco con cibi introvabili e bere quello che è comunemente chiamato un “caffè caffè”.dettagli
-
7 dicembre 1943"Siamo in viaggio per terre lontane"La famiglia Dalla Volta viene bloccata in casa da cittadini “zelanti” durante il rastrellamento degli ebrei effettuato a Bologna dalla polizia italiana nei primi giorni di dicembre. Alfredo Dalla Volta, impiegato delle poste e membro della Comunità israelitica, i figli Paolo e Anna, la moglie Marta Finzi vengono facilmente catturati. Il 7 dicembre, nel corso del viaggio che li porta al lager riescono ad inviare ad un amico una cartolina postale: “Carissimi, siamo in viaggio per terre lontane pieni di fiducia e con l'animo a voi rivolto. Speriamo che Dio ci assista e di riabbracciarci un giorno”. Nessuno di loro tornerà mai più.dettagli
-
11 dicembre 1943La "Santa Cecilia" di Raffaello ricoverata sull'isola BorromeoIl quadro raffigurante L'estasi di Santa Cecilia di Raffaello, capolavoro della Pinacoteca Nazionale, è trasferito durante la notte dell'11 dicembre verso la Lombardia. Francesco Arcangeli, giovane assistente di Roberto Longhi, lo accompagna lungo la via Emilia fino al traghetto del Po, nei pressi di Piacenza. Qui il quadro è accolto da Gian Alberto Dell'Acqua, che lo ricovera sull'Isola Borromeo al lago Maggiore, al riparo degli eventi bellici.dettagli
-
15 dicembre 1943Arresto di Dino ZanettiIl 15 dicembre viene arrestato Dino Zanetti. Nel 1919 fu promotore della formazione paramilitare nazionalista dei Sempre pronti per la Patria e per il Re. In seguito aderì al Fascio, divenendo uno degli squadristi più attivi. Il 26 luglio 1943 ha fatto esporre il tricolore con lo scudo sabaudo davanti a una banca di Cento (FE), della quale è direttore. Il 13 febbraio 1944 sarà condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale straordinario provinciale di Ferrara. Verrà scarcerato solo al termine della seconda guerra mondiale.dettagli
-
15 dicembre 1943Attentati dei GAP con ordigni esplosiviAlle ore 17,45 del 15 dicembre esplode una bomba nella sede di un reparto cartografico tedesco a Villa Spada, in via Saragozza. Poco dopo un altro ordigno distrugge un bordello per ufficiali in via San Marcellino. Le azioni sono opera di due gruppi di gappisti, guidati dal comandante “Dario” (Ilio Barontini), il quale, giunto a Bologna in ottobre, ha impiantato una officina clandestina per la confezione di esplosivi. I Gruppi d'Azione partigiana (GAP), promossi dall'organizzazione comunista, sono “gli arditi della guerra di liberazione, i soldati senza divisa, i più audaci, i più rapidi e pronti” (De Micheli). Per il momento sono solo una decina di uomini, votati a combattere in mezzo al nemico, pronti a colpirlo all'improvviso. Il 18 dicembre il comandante del Servizio di Sicurezza tedesco anticipa il coprifuoco alle 18, multa la città di 500.000 lire e promette 100.000 lire di premio a chiunque aiuti a individuare gli autori degli attentati.dettagli
-
16 dicembre 1943A Imola bombe contro la caserma della miliziaLa sera del 16 dicembre i Gap di Imola fanno esplodere due bombe su un davanzale della caserma della milizia, in Palazzo Della Volpe. Il questore di Bologna istituisce un premio di 100.000 lire per chi fornisca indicazioni utili alla cattura dei colpevoli. Il 4 novembre precedente i partigiani Adelmo Bartolini e Livio Poletti hanno giustiziato il seniore della 68a Legione Germano Fernando Barani. Per l'attentato del 16 verranno arrestati 23 cittadini. I fratelli Alfredo e Romeo Bartolini saranno torturati per più giorni e infine uccisi il 27 gennaio 1944 al Poligono di Tiro di Bologna.dettagli
-
19 dicembre 1943Don Giulio Salmi cappellano dei rastrellatiDon Giulio Salmi (1920-2006) viene ordinato sacerdote dal cardinale Nasalli Rocca. Pochi giorni dopo diviene il cappellano della Pro. Ra. (Pro Rastrellati), addetto al conforto religioso di quanti, in attesa di essere deportati nei campi nazisti o costretti a lavorare per la Todt sul fronte italiano, sono rinchiusi nel campo di smistamento delle Caserme Rosse alla Bolognina. Si tratta di migliaia di uomini catturati dai tedeschi in ritirata con razzie nelle Marche, in Umbria, in Emilia e soprattutto in Toscana. Tra essi anche una ventina di sacerdoti e seminaristi, ai quali don Salmi procura un altarino da campo che consente loro di celebrare ogni giorno una messa. Operando costantemente per la salvezza dei prigionieri, a rischio della vita, il giovane prete riesce a sottrarne parecchi al lager, indirizzandoli verso centri di raccolta preparati nel collegio di San Bartolomeo, nel seminario ONARMO di via Valverde, nel ricreatorio “Salus”, nel convento del SS. Salvatore. Impedito, pena la morte, a svolgere servizi religiosi all'interno del campo - i tedeschi si sono accorti che le sue omelie contengono messaggi per i rastrellati e indicazioni per l'evasione - viene infine cacciato fuori a calci dalle SS nell'ottobre '44,. Più tardi otterrà nuovamente il permesso di portare conforto ai prigionieri concentrati nella caserma di artiglieria a Porta D'Azeglio. Nel dopoguerra don Salmi verrà riconosciuto partigiano nella 6a Brigata "Giacomo" e insignito della medaglia d'oro dei comuni e delle provincie di Bologna e Lucca. Come responsabile dell'ONARMO, sarà in seguito animatore di case per ferie e strutture di accoglienza per lavoratori.dettagli
-
20 dicembre 1943Partigiani bolognesi nel VenetoNell'autunno-inverno del 1943 il CLN regionale stabilisce di ridurre drasticamente il numero delle bande partigiane in Appennino, ritenendo che la zona non si presti per la guerriglia. I sopralluoghi fatti a Vado, Monterenzio, Lizzano per stabilire nuove basi sono stati infruttuosi. Secondo un rapporto, datato dicembre 1943, del segretario comunista Giuseppe Alberganti (Cristallo), le “condizioni ambientali e geografiche” sono sfavorevoli: le montagne bolognesi non hanno un retroterra profondo, sono sprovviste di boschi e la buona viabilità permette efficaci rappresaglie. Inoltre in Appennino l'antifascismo è più debole e la popolazione, ancora succube del fascismo, dimostra di temere i Tedeschi e non ha manifestato alcuna reazione dopo l'8 settembre. Così, dopo accordi intervenuti tra la federazione del PC bolognese e l'organizzazione comunista padovana, a partire dalla seconda decade di dicembre più di cento giovani partigiani bolognesi vengono trasferiti a piccoli gruppi, con una “lunga marcia” piena di pericoli e difficoltà, nelle prealpi bellunesi. Alcuni di essi torneranno dopo poche settimane sotto le due torri per combattere nei primi nuclei della 7a GAP. Altri resteranno al Nord, inquadrati nelle divisioni “Belluno” e “Nannetti”. Quest'ultima formazione, dedicata all'eroe di Spagna Nino Nannetti, opererà fino alla Liberazione nelle valli del Mis e di Mesazzo e poi nel Vajont e sull'Altipiano del Cansiglio. Saranno 17 i partigiani bolognesi caduti in Veneto, tra cui il Tino Fergnani (1915-1944), primo ucciso in montagna nel gennaio 1944, e il comandante della Brigata Garibaldi “Mazzini” Francesco Sabatucci (1921-1944), nome di battaglia Cirillo, Medaglia d'oro al V.M. Mentre molti giovani resistenti bolognesi vengono inviati sulle Alpi, gli antifascisti imolesi scelgono di rimanere sui monti della Romagna, assieme ai faentini e ai ravennati, sconfinando a volte in Toscana sul monte Falterona.dettagli
-
28 dicembre 1943Attentato gappista al ristorante DianaUna bomba è collocata dai partigiani presso il ristorante Diana, in via Indipendenza, sotto un tavolo solitamente riservato ai militari tedeschi (o forse all'esterno vicino a una serranda abbassata). Lo scoppio provoca invece per errore la morte di due civili e il ferimento di altri cinque. Il tragico esito dell'azione partigiana mette in crisi questo tipo di tecnica terroristica tra le file dei gappisti. Uno di essi decide di abbandonare la guerriglia urbana e di andare a combattere sulle montagne. Intanto la polizia pone una taglia di 100.000 lire sugli esecutori dell'attentato.dettagli
-
30 dicembre 1943Prima fucilazione di partigiani al Poligono di TiroIl 30 dicembre avviene la prima fucilazione di “ribelli” al Poligono di Tiro. Si tratta di due giovani faentini poco più che ventenni, Marx Emiliani (Max) e Amerigo Donatini (Baratieri). Facevano parte della formazione partigiana “La Scansi”, guidata da Nino Cimatti e Gino Monti e operante nelle valli del Lamone e del Montone. Assieme ad altri ragazzi, tra i quali Silvio Corbari, avevano formato un gruppo gappista motorizzato, noto come la banda del “camion fantasma”, che, indossando divise naziste e viaggiando su un automezzo sottratto ai tedeschi, aveva seminato scompiglio in tutta la Romagna, disarmando caserme, posti di blocco e pattuglie fasciste e tedesche a Solarolo, Russi, Castel Bolognese, Cotignola. I due sono stati catturati dopo uno scontro a fuoco, avvenuto il 4 novembre a Villa Fontana, nei pressi di Medicina, in cui sono rimaste uccise quattro persone, tra le quali il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Roberto Roggero e la guardia municipale Armando Bosi, triumviro del Fascio repubblicano di Medicina. Il 29 dicembre il Tribunale Speciale di Bologna li ha condannati entrambi alla pena capitale. A loro – e ad altri tre antifascisti fucilati alcuni giorni dopo - è dedicato il primo bando bilingue affisso dal Comando militare tedesco, a scopo intimidatorio, sui muri di Bologna.dettagli