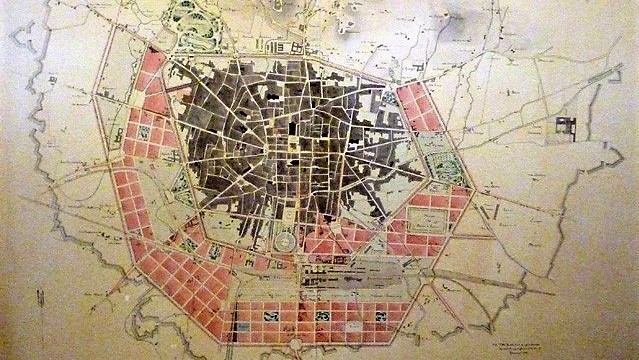La Società di Cremazione
Un gruppo di liberi pensatori, affiliati alla massoneria, fonda la Società bolognese per la cremazione dei cadaveri. La pratica è da poco prevista, come misura di igiene pubblica, da una legge voluta dal governo Crispi.
Per i massoni la cremazione è anche una scelta polemica contro la cultura cattolica, che considera l'inumazione come modalità esclusiva di seppellimento dei defunti.
Il 5 luglio 1889 entra in funzione un'Ara Crematoria della Certosa. La sua concessione ha costituito un motivo di contrasto, non solo tra laici e cattolici - questi ultimi la considerano addirittura un “losco affare” - ma all'interno stesso del mondo liberale.
Contro di essa si sono espressi personaggi come Giuseppe Grabinski e l'ing. Ceri, che ha addirittura promosso petizioni, definendo la cremazione, usanza "degli antichi pagani" e "contraria ai dettami della scienza".
In passato la Loggia "Rizzoli" ha chiesto al Municipio "la concessione di un'area di terreno del Cimitero comunale, in campo aperto, onde ridurlo a cimitero massonico". In seguito ha chiesto l'assegnazione di un arco di portico da dipingere con simboli massonici, in memoria dei Fratelli defunti. Nessuna delle due proposte ha, tuttavia, avuto seguito.
Nel 1895 alla Certosa sarà solennemente inaugurata la Sala delle urne: un corteo di parenti depositerà le ceneri dei defunti nel luogo del perpetuo riposo.

- Cimitero comunale della Certosa (BO)

- Cimitero comunale della Certosa (BO)

- Cimitero comunale della Certosa (BO)

- Sala delle urne del Cinerario - Cimitero comunale della Certosa (BO)
- 101 cose da sapere sulla Certosa di Bologna, a cura di Roberto Martorelli, Argelato, Minerva, 2023, scheda n. 75
- Carlo Manelli, La Massoneria a Bologna dal XII al XX secolo, Bologna, Analisi, 1986, p. 117, 123
- Giampaolo Venturi, Episcopato, cattolici e comune a Bologna, 1870-1904, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, stampa 1976, p. 169
- Giampaolo Venturi, La prassi della cremazione tra Otto e Novecento, in: in: Di fronte all'aldilà. Testimonianze dall'area bolognese, atti del convegno di studi Bologna, 7-9 novembre 2002, Bologna, Barghigiani, 2004, pp. 379-380